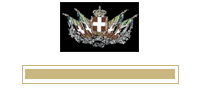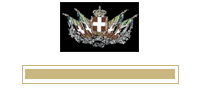| |
|
|
| |
:: Aggiornamento sito - Donazioni ::
|

Cari visitatori/iscritti di Fronte del Piave, Fronte del Piave ha bisogno del vostro aiuto.
È arrivato il momento di aggiornare tutto il sito.
------------- Aggiornamento -------------
Siamo felici di potervi comunicare che l’aggiornamento del sito è iniziato e la prima fase è completata, ma siamo ancora lontani dalla fine dei lavori e dalla cifra necessaria.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato fin ora e speriamo molti altri si uniscano a noi per salvare Fronte del Piave.
Maggiori informazioni e aggiornamenti qui. |
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
|
X.
IL CROLLO DI UN MONDO.
La prima notte e il primo giorno di pace. - La sommossa di Portogruaro. - I comitati di Salute Pubblica. - Nel regno dei bolscevichi.. - Trieste. - Le croci del Vallone e le campane di Aquileja.. - Oslavia e Gorizia. - L'Austria se ne va... - Il piano austriaco. - Un ultimo diario austriaco. - La Cassa Veneta dei Prestiti. - L'Istria. - Lo spirito slavo e i fatti di Fiume. - Una battaglia di fiori. - Morti del Carso, addio!
La prima notte il primo giorno di pace.
5 novembre 1918.
Abbiamo trascorsa a Castion di Strada la prima notte di pace.
Cos'è una notte di pace dopo tre anni e mezzo di guerra? E' una notte bianca, popolata di sogni e di ricordi, turbata da qualche inquietudine e da molte incertezze. E' proprio vero che è finita la guerra? Non sentiremo più dunque il cannone? E che diranno i nostri figliuoli? Che faranno i «borghesi» nelle nostre città?
Vedo Milano sventolare le sue bandiere; vedo, in una lontana prealpe, i miei figli arrampicarsi sul tetto della casa per appendere il tricolore al parafulmine, sciogliendo il voto antico. E i morti sentiranno? I morti di Oslavia e dell'Hermada, oramai dimenticati da tanta gente, verranno a sapere che l'Italia ha vinto, che oggi l'umanità riprende il suo cammino per le riaperte vie del mondo; che presto i popoli saranno riconciliati?
Sì, è finita la guerra, perché all'alba tutto il paese è a rumore. Le donne piangono e abbracciano i soldati; i bimbi sventolano bandiere di carta; arrivano frotte di uomini laceri e immondi; uomini trasfigurati, dalla miseria e dai patimenti, in spettri. Sono i nostri prigionieri che vengono da Lubiana, dove sono state aperte le porte dei campi di concentramento; no, i cancelli dei cimiteri. Portano panni ai piedi anziché scarpe, cappelli da borghese, qualche giubba austriaca. Ma Udine è occupata? Nessuno ne sa nulla; non resta che andarci. Anche qui da ogni viottolo, da ogni strada, da ogni casolare, viene gente alla strada a gettar baci ed evviva.
A Pozzuolo sventola una bandiera bianca, issata ieri dagli austriaci nell'andarsene. Dalla spianata del manicomio ci appare Udine, bella fra le trasparenze del cielo imbronciato, colla mole quadrata del castello, quasi a proteggerla.
- «E' libera Udine?», si chiede. - «Libera, libera, benedetti!»
Sì, Udine è libera; i ragazzi sono già sulle strade. Vi è entrata per prima un'ardita pattuglia del «Savoia» col tenente Baragiola, seguita da uno squadrone del «Foggia».
La liberata città apre porte e finestre; Udine ride nella gioia del sole finalmente riapparso; la statua di Garibaldi è infiorata; anche Vittorio Emanuele tiene in mano un gran mazzo di fiori. Tutto il popolo è in piazza, sotto la vecchia loggia del Comune, dove la gente fa crocchio attorno alla barba bianca dell'avvocato Linussa, che racconta gli orrori delle giornate servili. Ci sono già parecchi profughi rientrati, eroi della sesta giornata, e sono i più prodighi di abbracci e di evviva.
Ma ecco Attimis e Montegnacco, gli ufficiali della Giovine Italia, ancora vestiti da contadini, sorpresi nei pressi di Udine dalla precipitante vittoria. Questa è gente che si abbraccia volentieri, con occhi umidi di gioia!
Si corre qua e là a salutare qualche parente, a ricevervi e a lasciarvi una lacrima per ricordare qualche persona perduta, ma le lacrime d'oggi sono tutte lacrime di gioia.
Udine è sudicia, guasta, immiserita, in qualche luogo fetente, ma Udine è libera; ebbra di gioia e di sole, di pianti e di canti, Udine è felice.
La sommossa di Portogruaro.
6 novembre.
Finalmente c'è un paese che si è dato il lusso di una vendetta. Portogruaro, la più veneta fra le vecchie cittadette venete, la capitale valliva, fragrante ancora delle reminiscenze di Ippolito Nievo, coi portici e i poggioli di pietra d'Istria e gli archi sopra le vie; la cattolica Portogruaro ha scacciato a furor di popolo il suo vescovo perché ritenuto austriacante, lo ha insultato, bastonato, inseguito; ne ha saccheggiato il palazzo, e ne ha visto salire..., indovinate chi?, don Celso Costantini, il dolce prete di Aquileja e di Mogliano.
Abbiamo fatto colazione presso di lui; magra colazione, in una povera cucinetta accanto al fuoco, ma abbiamo avuto la soddisfazione di bere il vino del vescovo spodestato, verso il quale don Celso ha parole di cristiana indulgenza. Era ospite pure il parroco di San Donà, don Sarretta, al quale gli austriaci, non contenti di avergli distrutta la parrocchia, tolsero per due volte la libertà. Onore a lui.
Don Celso è un vescovo ideale: modesto come prima, buono come prima, entusiasta della patria, come prima. E, come prima, ha accettato le nostre sigarette e ha pianto brindando all'Italia.
*
Ci siamo fermati davanti al palazzo dei Foligno ad ascoltare i racconti della loquace guardarobiera. Gli austriaci vi hanno rubato tutto, le sedie antiche, i quadri, le gioie, gli arazzi, e hanno sventrata la cassaforte. Le sedie sono state imballate, incassate e spedite in Austria; ma l'astuta guardarobiera è arrivata a tempo a strappare uno dei cartelli e di sorprendere così il nome del ladro. Eccolo: «Rittmeister Rischard Baron, Pfungen». Ah, barone ladro!
La brava donna, per mettere in salvo le posate d'argento, le aveva portate all'arcivescovado e qui, fin che ci stettero gli austriaci, furono rispettate; ma il giorno della libertà, fra le cose buttate dalla finestra dal popolo esasperato, ci furono anche le posate che vi erano entrate, di contrabbando, per la porta.
I comitati di Salute Pubblica.
A San Giovanni al Tagliamento passa un reggimento austriaco prigioniero. Un contadino, certo Francesco Gasparotto, grida contro di loro: morte all'Austria!, e racconta che l'ultima notte penetrarono nella sua casa per rubare l'ultimo lenzuolo sul quale giaceva il bambino ammalato. Ne avranno fatto una delle molte bandiere di pace...
Si passa il Tagliamento a Latisana, lo Stella a Palazzolo. Fra Muzzana e Zellina vi sono molti carriaggi abbandonati e molti morti; altri morti dopo San Giorgio di Nogaro; a Torre di Zuino stormi di corvi volteggiano sui cadaveri.
Si saluta con devozione la colonna del vecchio confine e si entra in Cervignano, fra strade ingombre di elmi, di sacchi, di carte, di rottami.
Qui, allo scoccare dell'armistizio, sono entrati lancieri e cavalleggieri della brigata Filippini (Aosta e Piemonte Reale), colla 10a squadriglia delle autoblindate, i fanti della brigata Novara e pattuglie del 7° ciclisti; qui si arresero, prigionieri, il generale Fischer, comandante la 46a divisione Schützen, i quattro colonnelli e circa seimila uomini. A Sesto al Reghena i ciclisti avevano combattuto assieme alla popolazione.
Il comando della brigata Novara è alloggiato alla villa Antonelli, un tempo residenza del duca d'Aosta. Il proprietario, certo Dreossi, ufficiale austriaco ferito, disse al generale Torti: - «Il bolscevismo dalla Russia è passato in Austria, e, trattandosi di malattia contagiosa, entrerà anche in Italia». I fanti della «Novara» volevano però bastonarlo.
Questi fanti la mattina del primo novembre erano sul Piave, alla sera sulla Livenza, il giorno due sul Lemene, il tre sul Tagliamento, il quattro a Cervignano; ottantaquattro chilometri in quattro tappe; quattro corse da un fiume all'altro, e ad ogni fiume un combattimento. - «I fanti volavano, racconta il colonnello Bruscagli, sopratutto quando a Torre di Mosto trovarono cinque donne morte di fame».
Il giorno dell'armistizio, alle quattordici, la brigata arrivò in tempo a fermare un lungo convoglio di carri sui quali gli austriaci tentavano portar via quanto era rimasto alla povera gente del luogo: vitelli, molti maiali, biancheria, mobilio. Costretti alla fuga, uccisero a baionettate i cavalli. La popolazione si riprese i suoi maiali.
Scaduto l'armistizio, un battaglione Schützen non volle gettare le armi e, ai comandi di un maggiore, continuò a battersi, prendendo di mira l'automobile che trasportava il generale Torti col generale Fischer prigioniero. Al comando di arrendersi, imposto dallo stesso Fischer, il maggiore rispose: - «Non obbedisco ai miei inferiori, e un generale prigioniero è sempre, davanti a me, un inferiore». Si arrese soltanto quando si vide circondato.
*
Cervignano ha esposto bandiere italiane e ha costituito il suo «Comitato di Salute Pubblica» aperto a tutti i partiti, ma di evidente intonazione socialista. Si vanta di essersi costituito, per quanto non ufficialmente, prima di quello di Trieste.
Il 31 ottobre questo comitato ha dichiarato il suo distacco dall'Austria e, appena entrati gli italiani, ha pubblicato un manifesto che comincia così: «La libertà ha trionfato»; e finisce: «un velo sul passato; non odio, non vendetta, ma pace, amore, libertà».
Il colonnello Budiner, quando seppe che il comitato dichiarava l'indipendenza di Cervignano dall'Austria, non osò nemmeno protestare, perché virtualmente l'impero non esisteva più. E le autorità politiche consegnarono ai pacifici rivoluzionari la posta, il tribunale e l'ufficio delle imposte, dove gli impiegati continuano a tirare il carrozzone, come nulla fosse avvenuto. Domani cambieremo lo stemma, e l'i. r. impiegato tornerà puntuale al suo tavolo.
La cittadina era stata saccheggiata dai germanici, nell'occupazione del novembre; gli austriaci invece la rispettarono, come risparmiarono tutte le terre irredente. La ferocia e la rapina furono serbate alle terre invase. Mentre a Cervignano furono destinati 250 grammi di farina per persona, i paesi fra Piave e Isonzo furono condannati a vivere, e spesso a morire, con 100 e talora perfino con 50 grammi.
Il Lavoratore di ieri annuncia le clausole dell'armistizio. L'Austria si è arresa a discrezione, ma ha ancora qualche amico. Lo stesso Lavoratore ostenta un'aperta indifferenza verso l'Italia.
Il generale Torti ne è sdegnato. «Non per me, dice, ma per i miei morti, che sembrerebbero caduti invano».
*
Cervignano è il limite raggiunto colle armi il giorno dell'armistizio. Di qui a Trieste il territorio è zona neutra, occupata da bande bolsceviche, si dice. Monfalcone ha mandato una delegazione per affrettare l'intervento italiano, onde rimettere l'ordine.
Ma ci saranno proprio i bolscevichi? Lo vedremo domattina.
Nel regno dei bolscevichi.
7 novembre.
Guida la marcia l'automobile del tenente Palermi, del comando supremo. Il regno bolscevico incomincia a presentarsi bene. A Villa Vicentina, intatta, si ricevono i primi saluti; a San Valentino c'è qualche bandiera italiana e qualche austriaco sbandato, indifferente. Si passa l'Isonzo al ponte di San Valentino. A Pieris la gente raccolta attorno alla statua di Elisabetta d'Austria saluta, a Begliano ci sono gli austriaci che guardano e popolani che ci gridano addirittura evviva; a Ronchi molti austriaci immiseriti; cannoni, mortai da 305, ragazzi che scappano con fucili, una bandiera tricolore che sventola in cima a un cipresso.
Monfalcone è nella condizione nella quale l'abbiamo lasciata. E' deserta. La grande nave, la Elisabetta, riposa sullo squero, morta per sempre. Splendido naviglio capace di duemila passeggeri, non le mancava che il varo, quando fu colta dalla guerra. E la guerra l'ha bombardata, bruciata, squarciata e ridotta, prima ad osservatorio, poi, a teatrino per i soldati.
Fra la nebbia appare la rocca; quota 10, quota 21, il Cosich, il Debeli, squallide ondeggiature di roccie irrugginite dai reticolati. Si avanza lentamente, reverentemente... Ecco l'Adria, colle tre ciminiere stroncate, ecco il Lisert col fitto canneto, quota 12, tutta rossa di reticolato, le torri di Duino, la fosca collina dell'Hermada. Si passa in silenzio il Timavo, che cammina limpido e stanco nella palude; si salutano in silenzio le macerie di San Giovanni, ultimo limite della nostra dura e sfortunata conquista, e si entra in Duino, che è tutta una rovina. Unico segno di vita, un soldato austriaco che bacia un bambino.
Da qui la strada è popolata di soldati austriaci randagi, umili, sospettosi ma rispettosi, gente che ritorna e cerca un pezzo di pane e una casa. Dal rovescio dell'Hermada, munito di tre ordini di reticolati, e null'altro, incominciano le pinete carsiche, oasi di verde in bianca petraia, e fra oasi e oasi, fra nebbie che vanno e nebbie che tornano, luccica un lembo di mare.
Nabresina e Prosecco sono tutte pavesate di bandierine slave, ma a Prosecco troviamo già i bersaglieri. La zona bolscevica è superata; via, non è il caso di lagnarsene!
Trieste.
Dalla costiera di Contavello, un colpo di vento ci presenta agli occhi un quadro abbagliante: una città bianca ed immensa sdraiata su di un tappeto azzurro. E' Trieste; poi altro colpo di vento e questa volta, più che un quadro, una visione: una zampa che si perde non si sa se nel mare o nel cielo. E' l'Istria!
Si scende, si scende, avvolti nella nebbia, ma colla visione ferma e lucente negli occhi, col cuore in tumulto. Alle porte della città, i bersaglieri ci chiedono i documenti.
- Siete contenti, ragazzi?
- Beati!
La città è imbandierata e popolata: popolata di cittadini ornati di coccarde italiane, di soldati austriaci che ostentano coccarde slave e sopratutto di prigionieri nostri, le più squallide figure umane che abbia mai vedute. Ma gli occhi nostri, abituati agli arsi paesaggi del Carso, ai borghi desolati di Castagnavizza e di Oppacchiasella, restano abbagliati davanti alla città opulenta ed intatta. L'oltraggio della guerra le fu risparmiato; l'Austria ha riservato alle terre d'oltre Judrio i sistemi di guerra degli Unni, fissando in due fiumi, come in due articoli di codice, i precisi confini del furto legale: Judrio-Piave.
In questo momento arriva al molo il piroscafo Gratz con altri 1200 prigionieri che chiedono pane, perché non mangiano da tre giorni. La gioia più grande affoga in questo spettacolo di dolore.
Ma la «piazza» è il luogo di riunione di tutti coloro che amarono e soffersero. Vi trovo Segrè, Barzilai, Zampieri, l'antico direttore dell'Indipendente, tutti i più noti fuorusciti, oramai tornati. E da essi si apprende il rapido e fortunato corso degli avvenimenti. Fu il giorno 29 ottobre che, reso evidente il rapido sfacelo dell'Austria, cominciarono i ragazzi a sventolare bandierine tricolori; alcune ragazze osarono mostrarsi con delle coccarde; furono arrestate; ma il moto popolare propagò. Fiume, la più generosa delle città italiane, sventolò per prima pubblicamente la bandiera e avvertì Trieste che proclamava la sua unione all'Italia. Qui la plebaglia cominciò a percorrere le vie per tentare qualche saccheggio; gli slavi, fatti audaci dall'esempio dei loro fratelli di Fiume, domandarono al Comitato di Zagabria l'occupazione della città, ma il Comitato oppose un rifiuto in omaggio agli accordi coll'Intesa; aperte le porte delle carceri a tutti i detenuti, l'ordine per un momento parve seriamente turbato, ma una compagnia czeca dell'esercito austriaco intimò il rispetto alle cose e alle persone, e lanciò essa stessa il grido di Viva l'Italia, nel nome di un'alleanza cementata dal sangue insieme versato.
Nel frattempo, l'elemento italiano si costituiva in comitato di Salute Pubblica e il 30 ottobre issava la bandiera nazionale sul palazzo del Comune e mandava a Venezia il podestà Valerio a invocare l'intervento italiano. Così si compiva la pacifica rivoluzione e domenica 3 novembre il piroscafo Roma sbarcava il decimo battaglione bersaglieri e duecento carabinieri. Appena il Roma si avvicinò al molo della Sanità, suonò il campanone di San Giusto; la folla si buttò verso il piroscafo per strapparvi i bersaglieri. Fu un delirio.
Trieste è tornata italiana, ma gli slavi non hanno disarmato affatto; ostentano coccarde e minacciano addirittura una nuova guerra. Wilfan, il capo degli sloveni, a un fuoruscito, credo il capo degli sloveni, a un fuoruscito, credo il Liebmann, che si augurava un'intesa «su tutto il resto, ora che Trieste è italiana», rispondeva: «adagio, caro»; al tenente Pizzarolo un ufficiale jugoslavo, che fece il viaggio con lui sul treno dei prigionieri, diceva: «Trieste sarà città libera, ma Gorizia non l'avrete mai; piuttosto faremo una nuova guerra». Il giornale croato l'Edinost, nel numero di ieri, incitava i suoi connazionali a tranquillizzarsi perché l'occupazione italiana non sarebbe stata che provvisoria.
Ma le cose finiranno per aggiustarsi per via. Anche i socialisti, dapprima, per far dispetto all'Italia, volevano proclamare Trieste stato autonomo e repubblicano, ma finirono col prevalere anche fra essi le correnti più autorevoli. Del resto, aveva buon fiuto il maggiore Lanek, capo della polizia militare, quando diceva che «a Trieste, anche scavando cento metri sotto terra, si finiva col trovarvi l'irredentismo».
Questo a Trieste; ma scavando la terra sul Carso, non si trovano che ossa italiane, fra i morti per la causa della libertà. Tutti gli altri morti son caduti per puntellare il vacillante trono degli Asburgo. Questo dovrebbe ricordare tanto i croati battezzati da jugoslavi, quanto i socialisti accesi d'improvviso amore per la repubblica. L'Italia sola, coi suoi soldati, ha fronteggiato l'Austria; l'Italia sola, col suo sangue, l'ha fatta cadere. La libertà è stata conquistata per tutti, anche per i nostri nemici, ma la libertà non può tollerare che sia oltraggiata la verità.
*
In via della Geppa incontriamo un gruppo di soldati czechi che salutano, un gruppo di slavi che guardano in faccia e tirano avanti; ma, al Ponte Rosso, uno di essi è fermato da un cittadino che gli grida: - «Spia, per tua colpa ho fatto quarantacinque giorni di carcere!»
Al palazzo del Comune, il sindaco Valerio riceve gli amici vecchi e nuovi. E' commosso. - «Mi duole solo, dice, che alla grande espiazione non assista Francesco Giuseppe».
I prezzi delle derrate e delle merci hanno subito un tracollo. La carne da 50 corone è scesa a 16, il burro da 120 a 52, la farina da 16 a 6, il thè da 240 a 30.
Ma i negozi sono pieni di ogni ben di Dio. Tutto quanto era stato dall'ingordigia degli speculatori nascosto, torna alla luce, persino il cioccolato (dicono delle donnette) «che da un anno non si vedeva più».
*
Arriva il Francesco Ferrucci, carico di bersaglieri. Dalle piazze, dalle strade, dai vicoli, vengono frotte, sciami, colonne, una fiumana di gente, a urtare contro il molo. Dalla nave sventolano bandiere e cappelli piumati, dalla riva ondeggiano berretti, fazzoletti, scialli; erompono evviva. Sembra che mare e terra si rispondano per incontrarsi nel nome d'Italia. Trieste in questo momento ha ritrovato la sua vecchia anima italiana. I soldati vestiti da austriaci scantonano; i prigionieri italiani sdraiati sulla banchina sembrano assenti dalla grande festa.
Le donne sono le più entusiaste. Due signorine, certe Migliarini e Bressani, raccontano con orgoglio di aver tenuto in casa per tre mesi tre prigionieri italiani, ma sono sdegnate per aver veduta la coccarda addosso a un tizio che il 24 maggio 1915 fu tra quelli che bruciarono la tipografia del Piccolo. Ma l'Austria è morta; anche i conigli gridano «viva l'Italia!»
*
Si sale a San Giusto, con crescente emozione. Davanti alla chiesa, un grande manifesto, in data 1° settembre 1918, dice: «Uno scatto di santo entusiasmo cancelli il triste passato!» E' un grido di guerra? No, è monsignor Bottignon, capitolare e parroco della cattedrale, che domanda elemosina «per abbellire di nuove decorazioni il tempio di San Giusto».
Ma davanti al tempio, ogni miseria muore.
San Giusto! Sulla tua torre quadrata madri vennero qui a pregare pei figli combattenti sotto le nostre insegne, quante altre vennero a piangere per quelli combattenti per l'impero maledetto!
Cadeva il sole e avvolgeva la sottoposta città e il mare tranquillo in un nembo di polvere d'oro. Dagli spalti del vicino castello, la città sembrava godere beata del doppio amplesso del monte e del mare; musiche lontane portavano fino a noi vecchie cadenze bersaglieresche. Che tu possa, o Trieste, godere nei secoli le gioie della rifiorita libertà!
*
Scendendo da San Giusto siamo assediati da uno sciame di ragazzi.
- «Siete contenti che siano venuti gli italiani?»
I ragazzi, in coro:
- «Sii!»
- «E perché?»
- «Perché i ne porta da magnar!»
*
Entrati in parecchi ristoranti, non vi abbiamo trovato che giornali tedeschi e slavi, nemmeno uno in lingua italiana. Ma questa sera, nelle vie risplendenti di luce, pel corso sfolgorante come una notte di carnevale, su ogni petto sono comparse coccarde tricolori. Le ho viste addosso a gente che portava la divisa austriaca e a persone che non parlavano che tedesco. Se domani arriverà un altro bastimento di bersaglieri, diventeranno italiani anche gli slavi!
Le croci del Vallone e le campane di Aquileja.
8 novembre.
Finalmente possiamo leggere i giornali. Quelli venuti dall'Italia portano la notizia che anche la Germania ha chiesto l'armistizio; il Lavoratore espone il suo nuovo programma nel quale preannunzia «giorni lieti» al nostro paese; la Nazione, il nuovo periodico, riporta il superbo discorso di Deschanel alla Camera francese, in cui così si parla di Roma:
«Oh Roma, città santa degli eroi, dei poeti e degli dei, a tutti i fastigi che rapiscono il cuore degli uomini, aggiungi la suprema bellezza: il ritorno della libertà».
Bisogna andare in Francia per sentire parlare così il Roma... Gli czechi hanno offerto all'Intesa un esercito di 50 000 uomini per marciare contro la Germania, «onde offrire ai nostri liberatori più che una platonica simpatia». Questo è linguaggio di gente degna della libertà.
*
Monfalcone in due giorni ha cominciato a rivivere. E' stata aperta qualche improvvisata bottega; sulla via ha messo banco un venditore di castagne calde. A Selz qualche rovina è rattoppata ed abitata. Uno slavo ci guarda esterrefatto: - «Oh i taliani!», e fa di cappello.
La strada per Doberdò è ancora mascherata; i ricoveri, le doline, le trincee sono quali le abbiamo lasciate. Nel paese nemmeno un'anima; siamo i primi ad inaugurarvi la vita. A Oppacchiasella c'è qualche austriaco randagio che forse cerca la casa; poi più nulla; il deserto, la morte. Si scende al Vallone, si piega la fronte davanti ai cimiteri. Fra le tombe è cresciuta l'erba; molti corvi vi girano attorno.
Sulla strada che porta a Gorizia, troviamo un bel ragazzo, solo, vestito da collegiale, che trascina una valigia. E' uno slavo di quindici anni che viene da Budapest, dove studiava. Torna a casa, per sempre. - «Ogni soldato, dice, ritorna alla propria nazione». E' indubbiamente una frase non sua.
- «Bravo! Pensa che prodigio si è compiuto; non ve n'è altro di così grande nella storia moderna. Ma guarda, caro, quanti morti questo prodigio ci costa! Guarda quante croci italiane...» Il ragazzo risponde: - «E' vero», e riprende la valigia. Poi si ferma e si volta a guardarci. E torna a salutare, quasi con affetto. I nostri occhi guardano altrove: al San Michele. (1)
*
Ripassando l'Isonzo, sentiamo lontani squilli di campane. Sono le campane di Grado e di Aquileja. Altri bronzi rispondono; l'aria trema di suoni. Il cimitero d'Aquileja, raccolto all'ombra della severa basilica e degli scuri cipressi, è tutto un sorriso di crisantemi; l'erba cresce fra le tombe, ma i crisantemi l'hanno superata.
Dalla fossa del generale Ricordi «aleggia lo spirito suo verso Trieste fidente», come dice la lapide; Luigi De Prosperi ripete dal sepolcro le parole del suo testamento: «Muoio contento di aver compiuto il mio dovere fino all'ultimo»; Randaccio dorme sotto il pesante sarcofago, semplice, austero, senza parole.
E' questo il cimitero dei cipressi e delle edere; il campanile dell'XI secolo lo veglia come un'immensa torcia e le campane suonano a festa come per allietare il sonno dei morti.
10 novembre.
Guglielmo ha abdicato. Il «signore delle battaglie» depone spada e corona. E' curioso che la Germania, dotta e possente, non sia riescita a fare del suo Kaiser quello che il popolino di Portogruaro, a ragione o a torto, fece del suo vescovo. Forse che il popolo lo assolva perché pensa che ha amato molto il suo paese?
(1) Il San Michele è nome che non ricorre mai invano. Nel correggere le bozze, l'animo mi porta a dire ancora una parola su questo colle fatale, il Campidoglio del Carso. Il monte San Michele fu conquistato dall'XI corpo d'Armata, comandato allora dal generale Cigliana. L'XI corpo d'Armata, raccoltosi nei primi giorni della guerra nei dintorni di Latissana, passò il 3 giugno 1915 il confine ad est di Palmanova, e il 5 prese Gradisca, raggiungendo l'Isonzo. Il 9 tentò di forzare il passaggio dell'Isonzo ad ovest di Sdraussina, ma la impresa fallì; al di là del fiume si ergevano le alture del Carso fortemente tenute dal nemico, e le truppe della brigata «Pisa», che nella notte sopra il 9 riuscivano a passare il fiume, si trovarono subito a contatto col nemico, prima che potessero guadagnare terreno. Rotto il ponte di barche dalla artiglieria nemica, esse non poterono venire rinforzate, e la notte seguente si dovettero ritrarre sulla sponda destra. Il passeggero del fiume avvenne il 18 giugno, quando il nemico si era portato più addietro. E' incominciato allora l'attacco del San Michele, o, per essere precisi, del famoso costone identificato dalle quote 170 e 141. La sera del 18 giugno, per la prima volta, le truppe dell'XI corpo d'Armata riuscirono a raggiungere la sommità del San Michele e vi passarono tutta la notte; al mattino successivo, attaccate da forze preponderanti, dovettero sgombrarlo; una seconda volta vi giunsero il 26 luglio, di giorno, ma purtroppo anche questa volta, dopo meravigliosa difesa, dovettero nuovamente abbandonarlo. Da quel giorno, rinunciandosi agli attacchi violenti, si iniziò una metodica avanzata per conquistare il difficile baluardo. Furono mesi e mesi di penosa lotta di trincea, durante i quali si guadagnò terreno metro a metro, palmo a palmo, con lavori di zappa, con scavo di gallerie sotterranee, fra ogni specie di insidie, con sacrificio quotidiano di vite umane. In quei mesi di lungo martirio, ogni tanto, si alternavano violenti attacchi che, se producevano qualche maggior guadagno, cagionavano ingenti perdite. Il nemico, per la difesa del San Michele, ricorse il 28 giugno 1916 ad un proditorio attacco di gas asfissianti che è rimasto fra i più lugubri ricordi della guerra: era allora in linea la brigata Ferrara comandata dal generale Rocca. Sorpresa dall'attacco, lasciati numerosi morti sul terreno, perdette le trincee che fronteggiavano la cima 3, ma per poche ore, chè, già prima di mezzodì, tutto il terreno perduto era riconquistato, e torme di prigionieri cadevano nelle sue mani. Né tardarono a spuntare i giorni della vittoria. Il 6 agosto venivano di lancio conquistate le quattro cime del San Michele; la tenace resistenza nemica impedì di procedere subito oltre, sì che si dovette lottare nei successivi giorni 7, 8 e 9 per rassodare la dura conquista, finché all'alba del 9 il nemico abbandonò le sue posizioni e si ritrasse alcuni chilometri addietro, al di là del Vallone. Impossibile enumerare i reparti che si sono immolati sul San Michele: tutta l'Italia, si può dire, ha dato il suo tributo di sangue e di ossa al colle fatale.
Oslavia e Gorizia.
14 novembre.
Ho fatto una scappata a San Floriano e a Oslavia. Il campanile di San Floriano segna ancora le otto e dieci, come in quel giorno lontano; la villa del barone Formentini è sempre verde di edere; il pennone della bandiera è ancora al suo posto.
Da Oslavia vengono canzoni. Sono donne, tornate da qualche tempo, che riprendono i lavori. La selletta è ancora tutta sconvolta, con le trincee e i camminamenti franati, i reticolati sopraffatti dalle erbe. Era questo «il catino» sul quale l'Austria, dal Sabotino, dal San Gabriele, dal Pannavaz vomitava tutto il suo fuoco, tutto il suo odio. Ma una famiglia, certi Gravner, vi ha già riattata, nei pressi, una casa e sui reticolati vicini ha disteso la biancheria al sole.
Sopra la selletta, biancheggia l'obelisco al generale Trombi, il comandante la IV divisione, caduto il 28 novembre 1915.
SACRA PIETRA MILIARE
SU LA VIA DELLA VITTORIA
A QUALUNQUE COSTO.
*
Anche Gorizia è, presso a poco, quale la lasciammo dopo Caporetto. Ma gli slavi si sono affrettati ad occuparla il 5 novembre, in nome del Comitato di Lubiana, a mezzo di quel 27° reggimento Schützen che dopo Caporetto si era dimostrato uno dei più accaniti ed inumani, ed ora è stato battezzato come jugoslavo. Solo oggi la loro bandiera fu abbassata dal palazzo del Capitanato distrettuale e issata, al suo posto, l'italiana.
Mi sono trovato col capo degli slavi, il dottor Podgornik, un immigrato, dal pizzo nero e dallo spirito ironico. - «Gli slavi, dice, non possono rinunziare a Gorizia, io però sono cosmopolita». Ieri un impiegato di banca, di diciannove anni, lacerò la bandiera italiana, ma per poco non fu strozzato dal maresciallo degli arditi della brigata Foggia.
Ma anche qui, la liberalità e la bontà del soldato italiano finiranno col rasserenare gli animi. Gli slavi sono un popolo giovane, esuberante, lungamente e sapientemente educato all'odio contro tutto ciò che è italiano. Quando esso venga messo a contatto coll'Italia e impari a giudicare gli agitatori che l'Austria aveva assoldati, il maestro ed il prete specialmente, finirà col diventarci amico. E si persuaderà che sotto il sole c'è posto per tutti.
Il corso Vittorio Emanuele III, intanto, è pavesato di festoni di edere, di bandiere italiane e slave. Quelle italiane sono fatte di carta, di velluti, di tappeti, messi assieme alla meglio mentre gli austriaci scappavano e i croati prendevano d'assalto gli uffici pubblici.
L'Austria se ne va...
15 novembre.
I giornali annunciano che anche Carlo ha rinunciato alla corona. I re se ne vanno, restano i popoli. Tanto meglio. Il Presidente Wilson ha detto che lo scopo della guerra è stato raggiunto. Zara, intanto, all'arrivo delle navi italiane è caduta in ginocchio sul molo e ha cantato gli inni della patria.
Vi è del poema, più che della storia, in tutto questo. «Ogni popolo, aveva detto il collegiale slavo, torna alla sua nazione»; speriamo vi torni con animo tollerante, con spirito purificato. Dall'immenso flagello dobbiamo uscire rinnovati.
Frattanto, arrivano i primi documenti coi quali è possibile ricostruire, sommariamente, le vicende di questo crollo fantastico.
La sua origine recente sta nella sconfitta austriaca sul Piave. Se l'Austria nel mese di giugno fosse riuscita ad andare a Venezia, i popoli, ubriacati dalla vittoria, avrebbero resistito ed obbedito ancora. Verranno presto i filosofi semplicisti a sostenere che il nemico fu vinto soltanto dalla fame, e sarà questa la tesi della Germania, che non si adatterà mai a confessare una disfatta militare; ma è tesi unilaterale e conseguentemente manchevole; la verità è che il nemico – e va detto a suo onore – aveva saputo risolvere da tempo il problema di vivere soffrendo quasi la fame. Dopo Caporetto, noi, percossi dalla vergogna, abbiamo vinto perché abbiamo «voluto» vincere, e in questa volontà disperata tutti i partiti e le classi sociali furono concordi; il nemico invece, dopo il Piave, ha perduto, perché ha smarrito per sempre la fede di vincere. Perduta la fede, non potevano non prevalere i consigli della fame e operare i fermenti dissolvitori che stavano in agguato. Perciò, la vittoria del Piave è stata decisiva non solo per la nostra, ma per tutta la guerra. Certo che la sorte dell'Austria era decisa da tempo e, per essa, da tempo la guerra era perduta, a cagione dell'inflessibile resistenza alleata sul fronte occidentale e dell'accanita resistenza nostra sul fronte italiano. Ma il rapido crollo è dipeso esclusivamente dalla vittoria del Piave, che fu mortale alla monarchia e all'impero. Era fatale, infatti, che la monarchia, perdendo la guerra, perdesse la corona, e i popoli, sciolti, più ancora che dal vincolo di fedeltà, dalla speranza e dal prestigio della vittoria, prendessero ognuno la propria via, trovando nella sconfitta la ragione di rivivere, sotto forme e reggimenti nuovi.
Il piano austriaco.
Il 16 ottobre, Carlo I pubblicava il manifesto che concedeva alle varie nazionalità il diritto di disporre di se stesse; il 23 l'Ungheria proclamava la propria indipendenza dall'Austria; il 24 avvenivano nelle retrovie ammutinamenti di truppa. I primi a ribellarsi furono gli ungheresi che a Buia, a Montenars e a Tarcento si rifiutarono di partire per il fronte. Contro di essi, a Gemona, furono puntate le mitragliatrici; a porta Udine e al sottopassaggio della stazione erano guardate dai fedeli bosniaci.
Quando il nostro comando supremo si è deciso ad attaccare, l'Austria si trovava in questa curiosa situazione: di avere davanti al nemico truppe sicure e non contaminate dallo spirito di rivolta; di avere, dietro a quelle, truppe, se non in tumulto, oramai consapevoli della dissoluzione interna. Non le restava quindi che una via, sgombrare gradatamente il territorio e mettere in salvo uomini e materiale, affidando alle truppe fedeli di mantenere, nel frattempo, ferma la linea davanti all'esercito italiano. In tal modo, essa sperava di evacuare tranquillamente, requisendo alla popolazione le ultime risorse. Il 15 ottobre, a Gemona, il burbanzoso colonnello Crevato, inviatava quel sindaco, avvocato Fantoni, a raccomandare al popolo di sopportare in silenzio le ultime requisizioni per non irritare quello che «anche ritirandosi, era sempre l'esercito vincitore». L'Italia, soggiungeva, «non può far nulla. Il su esercito è stanco; nell'Italia meridionale vi sono circa un milione di disertori, mentre noi non ne abbiamo che 500 000».
Questo piano di prudente ritirata, però, presupponeva la nostra inazione, come il piano della battaglia del Piave presupponeva la mancata resistenza italiana. Decisa invece la nostra offensiva, l'Austria dovette accettare, suo malgrado, la battaglia.
E la accettò, non senza speranza di un successo militare.
Furono fatti appelli disperati alle truppe del Grappa e furono rinforzate le linee del Piave. Il 26 ottobre la 34a divisione, infatti, che si trovava a Pordenone, si spostò verso il fronte e si ammassò a Colle Umberto.
E' falso, dunque, che gli austriaci non si siano battuti e che abbiano preferito ritirarsi ai primi colpi dell'artiglieria italiana. Essi, non solo si sono battuti, ma in un certo momento hanno sperato di mettere in iscacco l'Italia, illudendosi di salvare l'esercito e ottenere condizioni migliori di pace. Il bollettino austriaco del 28 ottobre segnala alla pubblica riconoscenza le truppe che resistettero fortemente «presso i villaggi di Moriago e Sernaglia»; quello del 29 riferisce che «si combatte con grande accanimento presso Valdobbiadene, a nord di Moriago e di Sernaglia, vicino ai ponti del Piave, a sud di Susegana, presso Tezze e San Polo»; quello del 30 ottobre esalta ancora le truppe del Grappa che «combattono in quelle posizioni con stoicismo ed eroismo senza pari». (1)
La Gazzetta del Veneto del 29 ottobre, che ho trovato a Udine, riferisce il comunicato dell'i. r. Quartiere della Stampa, da Vienna: «Le lotte alla fronte italiana sono terminate ovunque col pieno successo delle armi austriache. Dall'altipiano dei Sette Comuni al Piave, l'offensiva degli italiani, che si proponeva uno sfondamento, è completamente fallita».
Senonché il 27 ottobre gli italiani avevano già sfondato la linea «dei villaggi» a Sernaglia e le truppe delle retrovie tumultuavano. Boroevic imbarazzato telegrafava da Gemona all'imperatore che la posizione era insostenibile, e finiva col domandare «istruzioni». L'imperatore rispose che facesse per il meglio e che attendesse le istruzioni «per domani a mezzogiorno». Le cose, nel frattempo, precipitarono.
Il bollettino austriaco del 30 ottobre, ore 13,10, doveva confessare che «nella pianura veneta gli inglesi e gli italiani puntarono oltre, e, impiegando ogni sorta di mezzi di combattimento, riuscirono ad ampliare rilevantemente i settori di sfondamento a nord ed a sud del Montello. In conformità alla decisione più volte espressa di addivenire ad un armistizio e ad una pace che ponga fine alla lotta dei popoli, le nostre truppe che combattono sul suolo italiano sgombreranno il territorio occupato». Questa è la risposta a Boroevic.
L'ultima nostra battaglia, pertanto, fu quella della Sernaglia (che non so perché si tenti di chiamare battaglia di Vittorio), la quale la sera del 28 ottobre era oramai vinta. Successivamente non si ebbero che combattimenti fra avanguardie e retroguardie. Che se alcuni fra essi furono aspri e non brevi, come quelli di Sacile, di San Boldo e di Motta di Livenza, ciò dimostra ancora una volta che l'Austria ha potuto disporre fino all'ultima ora di truppe fedeli. (2)
(1) Non sarà fuor di proposito ricordare come, dopo le sanguinose giornate del 22 giugno e del 3 luglio 1918 a Bligny, dove i soldati italiani scrissero una delle più belle pagine della guerra, i nostri feriti, buoni giudici, raccolti a Parigi nell'ospedale della duchessa di Camastra, confermarono il giudizio che le fanterie austriache erano più temibili di quelle tedesche.
(2) Ecco – a illustrazione di quanto sopra – qualche dato sullo schieramento delle forze contrapposte sul fronte italiano nella ultima battaglia di ottobre. I dati sono, in parte, difformi da quelli portati dai comunicati ufficiali:
Divisioni austro-ungariche 63 ½; Divisioni alleate 57 e 1 reggimento, e precisamente: italiane 51, britanniche 3, francesi 2, czeco-slovacche 1, americani 1 reggimento.
Lo schieramento delle divisioni nemiche all'inizio dell'offensiva era il seguente:
1a linea 2a linea 3a linea
Dal mare a Palazzon 8½ 5½ 1
Da Palazzon a Pederobba 4 1 3
Da Pederobba al Brenta 9 2 2
Dal Brenta all'Astico 8 2 ? 3
Dall'Astico al Garda 4 - 2
Dal Garda allo Stelvio 5 - ½
Nelle lontane retrovie - 3
38½ 10½ 14½
TOTALE: Divisioni 63½
Nella battaglia di giugno le forze austriache ed ungariche sommavano a 65 divisioni; quelle alleate a 56, così ripartite: italiane 50, britanniche 3, francesi 2, czeco-slovacche 1.
Un ultimo diario austriaco.
A Trieste mi fu dato di leggere il diffuso diario di un alfiere del 12° reggimento di fanteria, appartenente a quella 33a divisione della quale si è parlato più volte. Mi limito a stralciare qualche brano caratteristico che dà luce sia alla battaglia di giugno, sia alle condizioni dell'esercito austriaco.
15 giugno 1918. «Ore 4 pom. Ciò che debbo vedere ora è incredibile! L'offensiva è completamente fallita. La nostra divisione è interamente impegnata, il 106° reggimento è completamente annientato. Molto probabilmente si finirà con una splendida ritirata. Mi sono aggregato ad un plotone di requisizione (1) e mi trovo all'argine.»
16 giugno. «Il Montello è nelle nostre mani. Il 106° reggimento ha avuto il 90 per cento di perdite.»
17 giugno. «Ecrastite e gas. I gas sono stati ingoiati dagli uomini stessi che li emettevano. «Alle 6 e mezzo le truppe d'assalto del 106° e 83° fanteria passarono il Piave. Qui cominciò il concerto. I pontoni vennero strappati, gli uomini annegarono a mucchi e, dopo un combattimento che durò fino a mezzogiorno, si fu costretti ad iniziare la ritirata.
«Ore 12 e venti. Si tennero discorsi per rialzare il morale dei soldati. Il Grappa è stato conquistato, il Montello pure. Il nemico ha resistito sul Piave solo fra Ponte di Piave e Susegana, ma è solo questione di ore e il nemico dovrà ritirarsi da queste posizioni.»
20 giugno. «Ieri sera spettacolo orrendo. Tutto il fronte tremava. I nostri attaccavano, avanzavano, gli italiani contrattaccavano. «Con gli italiani combattevano anche gli czechi in gran numero. Questi vengono soppressi non appena fatti prigionieri. E' mia opinione che l'offensiva sia completamente fallita.»
21 giugno. «Si dice che l'offensiva venga protratta fino al 29. Truppe germaniche dovrebbero arrivare di rinforzo per toglierci dalla m....»
22 giugno. «Villa Lavena. Ieri artiglieri czechi hanno rivolto i loro pezzi e sparato sulle nostre truppe. Sette colpi sono caduti a duecento passi di distanza da noi.»
24 giugno. «Le nostre truppe che avevano passato il Piave devono ritirarsi sul fiume.»
30 giugno. «Vienna è già prossima alla rivoluzione per la fame, Wekerle fece delle rivelazioni incredibili! Durante l'offensiva abbiamo perduto fra morti e feriti 100 000 uomini e 12 000 prigionieri. Tutte le truppe che coprivano la ritirata sono state fatte prigioniere.
«Si dice che la nostra imperatrice abbia tradito con sua madre il nostro piano di battaglia navale, causando l'affondamento della Szent Istvan.»
«Solo Dio può sapere quanto di vero vi sia in ciò. Una cosa è certa e cioè che la Monarchia non ha più lunga vita e che presto scoppierà la bomba.»
20 luglio. «Ci troviamo nuovamente in condizioni critiche. Il mio tenente Ghyern è preoccupatissimo. Gli italiani sono pronti all'attacco ed hanno portate le loro riserve a nord e ad est di Treviso. Noi non abbiamo affatto riserve! I nostri palloni sono sprovvisti di gaz e non possono salire. I nostri aviatori mancano di benzina e l'artiglieria di munizioni. «…. Il tenente Ghyern dice: «E' certo che saremo battuti.»
30 luglio. «Un primo tenente del 96° fanteria – tenente Stigny – (Karlevac) ha tradito tutto il nostro piano offensivo.
9 agosto. «…. Come sono diminuite le speranze in un buon esito della guerra: non se ne hanno più affatto! Tutti sono convinti che perderemo la guerra. Io pure sono convintissimo che verremo terribilmente battuti.»
30 settembre. «La Bulgaria offre la pace e chiede l'armistizio all'Intesa. Abbiamo dunque perso la guerra.»
10 ottobre. «…. Anche l'ultima speranza di pace sembra scomparsa. In ogni modo non può durare più a lungo. Noi siamo battuti su tutti i campi, militarmente ed economicamente.»
12 ottobre. «Wilson pretende prima dell'armistizio lo sgombero dei territori occupati. I nostri sarebbero d'accordo, ma a ragione non vogliono essere inseguiti. Sembra che non ci sia niente da fare colla pace.»
18 ottobre. «Da oggi siamo pronti a marciare. Tutto è stato imballato, le cose non necessarie sono state trasportate e gli uomini sono stati istruiti sulla disciplina durante la marcia. Per quanto si dice inizieremo in ogni modo la ritirata, perché non siamo più in condizioni di poter mantenere il fronte del Piave.»
21 ottobre. «Perché ci si fa sperare quando non vi è la sicurezza che le speranze si realizzino? Data la possibilità di una ritirata, il giorno 7 di questo mese non ci hanno mandato in linea. Stamane giunse l'ordine di dare il cambio nella sera alla 12a compagnia. Le speranze di pace sono scomparse. E, come per deriderci, dal paese ci chiedono: «Da voi dunque vi è l'armistizio?» Anche il Keha me lo scrisse oggi.»
22 ottobre. «In linea sul Piave. Ieri, in mezzo ad un fango asiatico, siamo arrivati qui. Vi è un fuoco molto vivace.»
25 ottobre. «Nervosismo terribile! Gli italiani sono pronti all'urto. Non ho dormito tutta la notte: ho atteso armato l'inizio dell'attacco, che ancora non è giunto. Lungo tutta la fronte si batte, si grida, si scava, si canta, si tossisce e si fischia.»
26 ottobre. «La battaglia è cominciata. Gli italiani hanno attaccato in montagna ma non hanno progredito. Una divisione inglese ha occupato la parte nord di Papadopoli. Un capitano fatto prigioniero ha detto che l'azione di montagna non fa che precedere l'azione principale che avrà luogo sul Piave.»
29 ottobre. «L'armistizio è prossimo. La guerra sarà presto liquidata, ma purtroppo non ci sarà risparmiata quest'ultima battaglia.» «Perché tutto questo? Io non ho più patria. L'Austria-Ungheria non esiste più. Il pio giuramento non mi lega più. Mi prenda il diavolo se io mi affaticherò ancora.»
Da queste e da altre pagine del diario, che pure è scritto da uomo di idee ribelli, risulta chiaramente come le truppe della prima linea si siano mantenute costantemente fedeli. Anche quando venne a vacillare la fede, supplì la disciplina, il pio giuramento. In un primo tempo tutte le truppe, senza distinzione di nazionalità, fatta eccezione di certi reparti czechi, si batterono; fra esse con particolare accanimento gli ungheresi e gli jugoslavi. Nel secondo ed ultimo tempo, tutti piegarono le ginocchia.
Parrà strano, ma da informazioni da me assunte risulta che, in questo secondo tempo, non ultimi a ribellarsi furono gli ungheresi. Fu contro di essi, infatti, che tornavano indietro, che a Gemona, nei pressi della stazione e altrove, dovettero puntarsi le mitragliatrici, guardate dai bosniaci.
(1) Se l'Austria aveva già pensato ai plotoni di requisizione, doveva avere cieca fede nella vittoria.
La Casa Veneta dei Prestiti.
E' stata istituita con ordinanza 3 marzo 1918 dal comandante del gruppo d'eserciti F. M. Boroevic. Al paragrafo 3° si dispone «che gli assegni della Cassa Veneta dei Prestiti sono mezzi legali di pagamento col pieno valore nominale in qualunque operazione monetaria».
E poiché i fatti successivi hanno dimostrato che questi buoni non erano coperti da alcuna garanzia, è ovvio quale grave precedente l'Austria abbia inaugurato nel mercato monetario.
Con successiva ordinanza 28 aprile, si disponeva che il comando del gruppo d'eserciti poteva imporre alle popolazioni il pagamento delle imposte e degli articoli di monopolio e di merci di importazione in corone, mentre era in facoltà di soddisfare tutti gli obblighi di pagamento verso le popolazioni in buoni della Cassa dei Prestiti.
Con l'ordine numero 53 826 del comando supremo di confessava lo scopo di queste disposizioni fraudolente:
«C.... 2. Si deve assolutamente evitare di effettuare dei pagamenti in corone alla popolazione nel territorio occupato.
«Questa disposizione è stata presa per non svalutare la nostra moneta, impedendo così una circolazione eccessiva ed artificiosa di corone nel territorio occupato».
Sono documenti, questi, degni di passare alla storia.
L'Istria.
16 novembre.
Un ordine del comando supremo affida ai granatieri il mandato di occupare entro domani la città di Fiume. Sarà questa l'ultima operazione militare della guerra.
Bisogna quindi portarsi a Volosca, limite estremo della nostra occupazione.
Si lascia Trieste per risalire la collina carsica al «Bosco del cacciatore», tutto verde di pini. La strada corre fra magri prati recinti di muri a secco, fra scure pinete e brughiere di ginepri, donde si levano branchi di gardene. Razovizza e Cosina sono paesi insignificanti, pavesati di bandiere slave; il paesaggio è sempre aspro, dominaro oggi da un vento agghiacciante, la bora. Finalmente c'è un campanile in cima a un colle: Loce Vele; più in là un grosso borgo rannicchiato sotto un fitto bosco di pini, Castelnuovo (Podgrad). Sfilano ragazze che vestono un chiassoso costume, con calze gialle e sottane rosse. E' questo il paese dei Ceci, ultimi residui di antica e piccola colonia romena, vittime essi pure della violenta denaturalizzazione operata dall'Austria che, in omaggio alla libertà, li obbligò a parlar sloveno. Ma è buona gente, vissuta sempre in armonia coll'elemento italiano.
Dopo Papa si scende verso la zampa dell'Istria, dove il paesaggio è interrotto da qualche aperta vallata erbosa e da rigogliose boscaglie di quercia; il fondo delle doline è seminato a grano. Le donne portano il gerlo, come in Friuli. Il clima si fa più dolce, la strada serpentina, i boschi di quercia hanno le foglie gialle come l'oro; a Perqua sventola la prima bandiera tricolare; a Muccichi troviamo i granatieri col colonnello Dina.
- «Che avviene a Fiume?» Fiume è stata già dichiarata italiana dal suo Consiglio Nazionale nella seduta del 30 ottobre, ma militarmente è in mano ai jugoslavi che hanno issata la loro bandiera sul palazzo del Governatore, e vi hanno installato un «conte supremo» certo Lanec, di antica origine italiana. La città è occupata da due battaglioni croati, da un battaglione di austriaci armati dai croati e da un battaglione di serbi chiamati dal comitato di Zagabria in aiuto ai fratelli di sangue. Dispongono di una cinquantina di mitragliatrici e di qualche pezzo di artiglieria antiaerea e hanno fatto sapere che, prima di lasciar entrare un italiano, si batteranno fino all'ultima goccia di sangue. L'ammiraglio Rainer, che comanda le nostre navi ancorate al molo, sta trattando da parecchi giorni col comitato jugoslavo per evitare un conflitto armato.
Si scende rapidamente, al cospetto del mare. A Matuji le doline, a ripiani degradanti, sono coltivate a viti, a ortaglie, a fiori; sembrano giardini; il paese è grazioso, con le casette alternate da vigne; poi la strada scende in ripidi serpeggiamenti, larga e pulita come i viali di un parco, a Volosca, la borgata deliziosa odorante di resine; risonante del mare, e da Volosca continua sempre, fra una successione di ville e di giardini, fino ad Abbazia, bella come un sogno di poeta, superba di ville, di pensions, di sanatori, di padiglioni, di ristoranti, di viali e di parchi, lussureggiante di allori, di lecci e di magnolie, una città bianca e lunga che viene, dalle falde del monte, a bagnarsi alla marina. E' questa la celebre residenza costiera alla quale affluiva, di primavera l'aristocrazia tedesca per la cura del sole, d'estate la plutocrazia magiara per la cura del mare.
Oh com'è lontana la guerra da questa azzurra e verde riviera! Qui le armi cedono ai fiori e le battaglie non possono essere state che battaglie di dame e cavalieri. Vi venne un giorno il marchese Di San Giuliano a convegno con Aerenthal e prese alloggio all'Hôtel «Quarnero»; vi venivano sovente a soggiornare i principi della famiglia imperiale; stanotte invece vi alloggeranno i mitraglieri... E vi staranno bene. L'albergo è sontuoso, con un'immensa veranda che guarda il mare. Siamo al centro del «passeggio» (Wegstrang) che congiunge Volosca a Laurana per la lunghezza di sei chilometri, tutto a risvolti, a terrazzi, con qualche giardino all'italiana, con gradinate che scendono agli scogli e ai piccoli porti, dove un tempo riparavano le barchette che portavano al mare gli innamorati e gli sfaccendati.
Alla Vier Jahreszeiten, la bella villa delle quattro stagioni, sepolta sotto i palmizi e sotto i lauri, è alloggiato il comando del 145° fanteria, il reggimento che tenne il Piave a Fossalta nel novembre 1917 e si battè alla Fossalta nel giugno. E' sbarcato il giorno 12 col Francesco Ferrucci, ricevuto entusiasticamente dagli italiani. Ma già il 4 novembre vi era sbarcato un sottotenente con 52 marinai, sollevando grande scalpore fra gli slavi.
I nostri fanti sono magnifici. Con gli scarponi grossi che calcarono la pietra del Carso e il fango del Piave, qui, sotto l'arco dei lecci e dei lauri, marcano il passo con grande dignità. Hanno intuito che sono qui a rappresentare l'Italia, e sono lieti e fieri della «funzione diplomatica» che sono chiamati a compiere.
Al caffè Lokey, un'orchestrina suona musica di Lehar, ma quando si attacca l'inno italiano, tutti sorgono in piedi. Ne resto meravigliato, ma il colonnello Bianchi mi spiega che le ostilità dei primi giorni sono andate dileguando, di fronte al contegno semplice, rispettoso, umanissimo dei soldati nostri. Gli slavi, che erano stati abituati a considerarci gente pezzente e feroce, sono rimasti meravigliati di trovarsi davanti soldati che rispettano le ragazze, che salutano entrando nei negozi e sopratutto che, non solo pagano quelle che comperano, ma dicono anche «grazie».
Lo spirito slavo e i fatti di Fiume.
I popoli, quando imparano a conoscersi, finiscono coll'amarsi o quanto meno a rispettarsi. Speriamo che si decidano a rispettarci anche i jugoslavi che finora mostrano di conoscerci poco.
Ho trovato qui alla «Villa delle quattro stagioni» il Primorske Novine del 14 novembre, con queste notizie:
«Da comunicazioni giunteci da Trieste, si sa che nell'Alta Italia scoppiarono grandi sommosse. A Torino e a Milano scoppiò la rivoluzione civile».
Il giornale riferisce poi che il tenente colonnello Maksimovc, comandante i 700 serbi giunti a Fiume, quando passò per Zagabria, la mattina stessa del 14, ha domandato quanti italiani si trovassero a Fiume e nei dintorni. Gli fu risposto: 13 000 e allora rispose: «Lake cémo mi s njima», il che vuol dire: «Sarà facile sbrigarcene», oppure «presto verremo alla fine». Poi, in un articolo dal titolo spregiativo «Prativ Talijanskih Zuluma», si narra:
«E' giunta a Fiume la torpediniera francese Touareg. Gli andò incontro il nostro capitano di Stato Maggiore Teslicu. Il comandante Durand disse che a Pola entrarono due torpediniere francesi e inglesi con ammiraglio americano per regolare contro gli italiani il possesso preso abusivamente. Teslicu si pose a disposizione del Durand congiungendo la nave con un filo elettrico e incaricando un plotone di soldati di sorvegliare il passaggio al molo. Il comandante francese già prese visione dei fatti accaduti ad Abbazia».
Siamo dunque nella terra dove le nazionalità si sfidano, guardandosi in faccia. Laurana italianissima guarda Castua croatissima, Fiume guarda Susak, mentre, nel cuore della penisola, Castelnuovo guarda a sé, e non parla né italiano né croato, ma sloveno. E gli ungheresi? Gli ungheresi abitano a Fiume, ma simpatizzano per l'elemento italiano, come quello che appartiene ad una civiltà superiore e dà garanzie maggiori d'ordine e di tolleranza. In tutti questi luoghi la nazionalità antica è l'italiana; italiano era, fino a poco tempo fa, lo spirito informatore dell'ambiente. Tale anche a Castua cinquant'anni fa era la vita; oggi stesso vi parlano italiano i vecchi e la gente colta. Gli slavi, popolo giovane, anelante alle ascensioni, aveva cordialmente aderito alla civiltà superiore, ma l'Austria, per imperare dividendo, mise in opera le sue vecchie arti intese a separare l'anima dei popoli, e, servendosi dei preti e dei maestri educati a tale opera, fece di Castua il maggior focolare dello slavismo. Il prete Spencic fu l'eroe di quest'impresa. Al caffè Lokey alcuni cittadini mi mostrarono dei documenti pubblici, libri tavolari, sentenze di magistrati dell'anno 1838, scritte tutte ed esclusivamente in lingua italiana, col sigillo della «Signoria feudale di Castua». Così in italiano erano scritte le sentenze del pretore di Volosca e in italiano fino al 1880, a Castua, a Volosca, a Buccari erano scritte le lapidi dei cimiteri.
Ma l''Italia, che fu la terra madre del principio di nazionalità, non può dimenticare a sua volta che la nazione è un fatto dinamico. Guai ai popoli che riposano e si lasciano sorpassare dalle schiatte concorrenti!
*
Giungono profughi di Fiume; sopraggiungono fiumani volontari nell'esercito nostro che vogliono entrare per primi nella città natale, donde sono usciti, come il capitano Gigante, con la taglia sul capo. E ognuno porta notizie, quelle notizie che danno di ora in ora materia alla Storia. Si vivono giorni di epopea.
La Croazia ha dichiarato la propria indipendenza, a Zagabria, il giorno 27; il giorno dopo il comune di Susak, alle porte di Fiume, vi aderì e una compagnia di croati che si trovava in Fiume, alzata bandiera bianca, prese d'assalto il tribunale, difeso ancora dalla polizia austriaca; liberò i detenuti, senza distinzione di crimine, e distrusse gli archivi. Il giorno 29 il comando militare, che era jugoslavo, dichiarò al governatore che declinava ogni responsabilità nei riguardi dell'ordine pubblico, e poiché il governatore si è affrettato a far le valigie, i croati si impossessarono del Governatorato, delle scuole, di tutti gli uffici pubblici e delle porte della città.
Ma il Consiglio nazionale, costituito di italiani, si radunava e rispondeva alla violenza con una memorabile deliberazione presa ad unanimità di voti, proclamando «in forza di quel diritto per cui tutti i popoli sono sorti a indipendenza nazionale e a libertà, la città di Fiume unita alla sua madre patria, l'Italia, attendendone la sanzione dal congresso della pace».
Questo avveniva il 30 ottobre. La situazione pertanto è delle più strane: il potere municipale è in mano degli italiani, quello militare e politico in mano dei croati; sul municipio e sulle case private sventola la bandiera tricolore; nei palazzi imperiali quella bianca e azzurra. I croati raccolgono i soldati che tornano dal fronte, li inquadrano in compagnie, li muniscono di coccarda jugoslava e li fanno girare per la città. E questi jugoslavi improvvisati fermano i cittadini, li perquisiscono, talora li derubano, alla sera piazzano le mitragliatrici per le strade e tirano qualche fucilata. Si sono anche impossessati del punto franco dove erano depositati trentamila fucili e molte munizioni.
I croati pretendevano che tutti gli impiegati giurassero fedeltà alla Jugoslavia, ma essi si rifiutarono, come i cittadini si rifiutarono di pagare a loro le imposte. Hanno fatto venire dai monti i contadini, con promessa di pagamento in riso, allo scopo di ingrossare i cortei, ma contro di essi gli italiani hanno messo in campo dimostrazioni di ventimila e più persone. Come si vede, la situazione è tragica, ma può anche apparire comica quando si pensi che dal giorno 4 novembre si trova ancorata nel porto la Emanuele Filiberto con due cacciatorpediniere, ma i marinai italiani non sono ancora sbarcati perché, da una parte il comando supremo mostra di volere occupare Fiume, dall'altra qualche ministro italiano ha raccomandato di «non urtare i jugoslavi». Per modo che l'Ammiragliato non sa da quale parte voltarsi.
*
Mentre a Fiume si dimostra nelle vie, a Volosca e ad Abbazia le beltà vaganti, rimaste disoccupate per la partenza degli ungheresi, cercano di adescare i nostri soldati, ma, almeno per il momento, non ci riescono. Il fante batte il piede sul selciato colla solennità di un diplomatico, perché sa che dormirà all'Hôtel Quarnero, come, in un tempo disgraziato, di San Giuliano, e ha già capito che oggi egli rappresenta qualche cosa di più di un semplice soldato. Ha già imparato a conoscere le ragazze del paese, ma le tratta con signorile gentilezza. E' per questo che gli umori verso di lui si sono in pochi giorni mutati.
Si parte per Castua. Al bivio di Perluca, i fanti del 145° reggimento perquisiscono gli austriaci che si dirigono a Fiume; a Belici arriva il colonnello Mancini del 6° artiglieria per piazzare i cannoni sulle alture che sovrastano Fiume. Eppure, si sente nell'aria che la tragedia finirà nella commedia...
Castua, bella e bianca, coll'ampia piazza che si sporge verso il mare come il ponte di una nave, offre il passeggero un panorama grandioso di mare e di monti: Fiume ai suoi piedi, davanti isole montuose in acque dalmate, colline istriane seminate di paesi, tutto intorno; deserte montagne di Croazia più in là.
Una loggetta del 1571 e il «borgo» separato dalla piazza da un arco, ricordano la vecchia civiltà veneziana; un glorioso avanzo di rocca attesta una più remota civiltà latina.
Ma, a sfidare l'antichità, biancheggia sotto la chiesa, la recente casa nazionale degli slavi, con la scritta grandiosa: Narodni Dom. nella sala del consiglio comunale il vecchio ritratto di Francesco Giuseppe è coperto da un foglio bianco, con le parole: «Zìvila Jugoslavia». Un manifesto di Jvan Poscic, presidente del comitato di Volosko, invita i jugoslavi a star tranquilli, perché «tutta questa linea di confine si manterrà per qualche tempo sotto la tutela dell'Intesa e dell'America, non della sola Italia». Il manifesto, scritto in forma suggestiva, simpatica, finisce così:
«Narode! Il grande Wilson (Veliki Wilson) si è messo in guerra perché la tua divina e sacra aspirazione, sia assicurata. Egli farà che anche noi jugo-slavi dell'Italia si abbia il nostro paese al sole, non come oppressi ma come padroni in casa nostra. Abbiamo sofferto ottocento anni, ma ora spunta anche per noi l'alba dorata della libertà! Zivio Wilson, Zivila Antanta».
Interrogo una semplice signora.
- «Siete italiana, signora? Sento che parlate a meraviglia la lingua nostra.»
- «No, sono croata. Parlo l'italiano coi civili e slavo coi contadini.»
Il colonnello Dina, che frattanto è arrivato coi suoi granatieri, ha dovuto richiamare all'ordine il podestà Jelusic che aveva fatto correre fra i contadini la parola d'ordine: «Non siamo usciti da una tirannia per cadere sotto un'altra». E poiché le parole imprudenti furono ripetute, abbiamo chiesto cortesemente a parecchi: - «Ma di grazia, quante goccie di sangue avete versato per abbattere la vecchia tirannia?» Questi discorsi ed atteggiamenti, di fronte a quei granatieri che hanno versato torrenti di sangue sotto l'Hermada – senza di che l'Austria non sarebbe caduta e la Jugoslavia non avrebbe osato dichiarare la propria indipendenza – fanno rimescolare il sangue. Ma quando, nel guardare giù dal parapetto della piazza, vedo di terrazzo in terrazzo, ogni palmo di terra coltivato con cura amorosa e dolorosa, e, più abbasso, fra la pietraia, le doline trasformate in giardini dalle donne che vi portano il letame col gerlo, penso al buon contadino della Valtellina, che ripete sui lontani monti lombardi la stessa fatica, al pastore della Carnia che sulle alte valli del Tagliamento trascina le capre a brucare le gemme dei faggi, al paziente lavoratore d'ogni paese che dà alla terra sangue e sudore. No; noi non possiamo odiare questa buona gente,paziente ed operosa, e quando taceranno coloro che l'Austria investì di un mistero d'odio e di diffidenza, italiani e slavi dell'Istria e della Dalmazia comprenderanno che sotto il nuovo sole c'è posto per tutti.
*
Arrivano fiumani a invocare l'immediato nostro intervento. Sono accompagnati da due giornalisti, Scarfoglio e Fraccaroli. Mentre si sta per muovere, sopraggiunge l'ordine di rimettere l'«azione» a domani. Buona notte.
Una battaglia di fiori.
17 novembre.
Le truppe muoveranno da Castua a mezzogiorno. Entreranno a Fiume alle quindici, per la quale ora si spera che i croati sgombrino. Ma si dovrà entrare in qualunque ipotesi. Brr!
La piazza di Castua è affollata di slavi venuti dalla montagna. Si distribuisce gratuitamente il Primorske, che invita i jugoslavi di Fiume e di Susak a trovarsi stamane dinanzi all'associazione nazionale (Naroden Citaonica) per una dimostrazione all'America.
Egregiamente; però sarebbe opportuno tener presente che sul Carso gli americani non c'erano.
Alle ore dieci arriva la notizia che i croati e i serbi se ne vanno. Bene! Alle undici e mezzo arriva un'altra notizia: non se ne vanno più. Male! La città dovrà esser presa a viva forza.
A mezzogiorno partono le truppe d'occupazione, divise in cinque colonne: granatieri, cavalleria Piemonte Reale, artiglieria da montagna, autoblindate della 10a squadriglia. Gli slavi assistono in silenzio all'imponente parata, sfoggiando le loro smaglianti coccarde.
Si scende a Dolcie, a Blecici, a San Nicolò. Qui gli uomini sono tutti sulla strada; visi di donne alle finestre socchiuse.
Alle tredici siamo colla pattuglia di punta alla colonna di confine, che reca: Limites Regni Hungariae, e sui due fianchi: Fiume, da una parte, e: Istria, dall'altra. Ma la parola Fiume è cancellata con un tratto di carbone e sostituita con: Rieka. No, caro sconosciuto, non è col carbone che si può cancellare la storia di Fiume, la Flumen di Paolo Diacono!
Dalla città arriva il maggiore Mercalli. Gli slavi della montagna se ne sono, in buona parte, andati, con chitarre e tamburelli, ma i serbi domandano tre giorni di tempo per partire. Frattanto l'ammiraglio Cagni ha perduta la pazienza e ha lanciato un radiotelegramma all'aria in cui denuncia la sopraffazione serba e ordina alle truppe dell'ammiraglio Rainer di occupare Fiume.
Due sentinelle slave ci intimano di gettare le armi. Successo di ilarità. Per tutta risposta, sono invitate a consegnare i loro fucili, ciò che si affrettano a fare. E se ne vanno all'osteria vicina a ordinare da bere. E' scena da operetta.
A Plasse San Nicolò, mentre si sta per entrare in Fiume, sopraggiunge un automobile con ufficiali inglesi e alti marinai italiani. Si capisce subito che si tratta di gente che vuol tirare in lungo. Ma il generale San Marzano risponde con un «no» secco. I granatieri, che hanno già intuito tutto, ridono. In un angolo della piazza le ragazze del sobborgo, fra le quali qualche splendido tipo di zingara, ballano al suono di un organetto, con movenze voluttuose. Poi si fermano per guardare i granatieri: - «Che uomini grandi!» Finalmente si riparte; in testa una punta di sedici granatieri, col maggiore Campolieti, subito dopo il gruppo dei generali e degli ufficiali: San Marzano, Anfossi, Dina, Liberati, Facci, Camastra... Mentre si scende, appare la città adagiata sui colli, distesa sul mare. Alle tre e trenta la punta arriva ai giardini pubblici. Trecento metri davanti a noi, nei pressi della stazione, stanno schierate le truppe serbe e czeche, ma mentre sta serrando sotto il reggimento granatieri,, appare la testa di un immenso corteo che agita bandiere tricolori. Sono gli italiani di Fiume che vengono incontro ai fratelli e dividono colle loro bandiere i due eserciti. Lo spettacolo non ha pari. Non è più operetta, ora, è dramma di popolo. Donne, bambini, vecchi si precipitano sui granatieri, li coprono di fiori, li bagnano di lacrime e di baci. Come per incanto, si rifoderano le baionette e sulle lucide canne dei fucili si infilano dei fiori; granatieri e popolani insieme confusi, procedono verso la città delirante che agita dalle finestre tutte le sue bandiere, che riversa da ogni balcone tutti i suoi fiori, che innalza al cielo la voce del suo grande cuore.
Davanti all'accademia militare si passa sotto gli occhi delle sentinelle serbe che si ritirano dietro le colonne; alla stazione si passa davanti a un migliaio di soldati di tutte le nazionalità slave che guardano in rispettoso silenzio. E chi, infatti, oserebbe turbare lo spettacolo di gioia di tutto un popolo che, dopo secoli di esilio, si porta incontro ai fratelli venuti dalla madre terra? Quando i capi esitano o tremano per difficoltà imprevedute, i popoli hanno sempre dei trasporti d'anima capaci di sciogliere, come per incanto, anche le situazioni più fosche.
Quel che avvenne di poi interessa medriocremente. La dimostrazione croata, inscenata sulla piazza del molo, nonostante le violente concioni dei tribuni che parlavano dal «caffè degli specchi», dovette squagliarsi quando le si presentò la testa del corteo italiano. La forza del numero e dell'entusiasmo si impose al buon senso popolare. Poco dopo, scendevano dalle navi marinai nostri e americani, e la bandiera italiana, a fianco di quella stellata, seguita dal popolo, mosse al palazzo del Governatore, dove fu issata, fra lagrime e plausi. Il dottor Lenac, che vi si era chiuso dentro, dichiarava di «cedere alla violenza» e domandava una scorta armata per tornare a Susak. Così finiva il breve regno del «supremo Conte», e la battaglia di fiori moriva, a sua volta, in una serata di canti. Tutta la notte le strade, le piazze e la riva del mare risuonarono di canzoni italiane. Sembrava che un cuore immenso sprigionasse la gioia lungamente repressa, lanciando al cielo un inno di gloria.
Morti del Carso, addio!
19 novembre.
Con una battaglia di fiori si è chiusa la lunga guerra. Ovunque, nelle città redente e in quelle liberate, arrivano a frotte uomini politici, sindaci, scrittori, tribuni e persino banchieri, tutta gente che vuol partecipare, sia pure in ritardo, alla gloria comune. Non resta, adunque, che andarsene. Gli amici sono salutati in fretta; prendiamo congedo ora dai morti, gli amici che non torneranno a casa mai più.
Anche oggi il Carso è deserto. A Devetaki un soldato fruga nelle rovine. E' un padrone che cerca una casa. Alzandoci sulla via di Oppacchiasella, si leva con noi, gradatamente, alle nostre spalle, il San Michele, come per ammonirci che i morti ne hanno fatto più alta la cima. Appaiono i Faiti, bianchi anch'essi, come fossero cosparsi di ossa. La strada è tuttora mascherata, come allora; le doline hanno ancora i fantocci contro i gas, come allora, le baracche e le croci, come allora; armi e munizioni abbandonate, come allora. Ecco Loquizza, ecco Segeti, bianche rovine nel deserto carsico; dolina Oneglia, bivio della Morte, dolina dei Briganti, dolina Laghetto, dolina del Castagno, con croci, dolina Duca, con croci, dolina Lecce Bassa, con croci; ecco, davanti a noi, una gran massa bianca, un mucchio di rovine: Castagnavizza. Gli alberi son morti, non vi sono che pietre all'intorno; pietre e croci, cespugli di ferro e croci di legno.
Nel salire alle rovine della chiesa, il cuore si gonfia. Le trincee sono quasi a contatto; a contatto le fosse e i ricoveri, le impronte della battaglia e quelle della morte. Qui il 26 maggio era arrivato il battaglione Bancale del 154° fanteria; a pochi passi da qui i nostri soldati sono rimasti inchiodati fino al 27 ottobre, colla morte pendente sul capo.
Fucili abbandonati sono appoggiati alle croci; nessuno li ha toccati da quel giorno lontano, come piede umano non ha violato i Faiti, che ci guardano come fantasmi bianchi. Hudilog, Nova Vas, Ferleti: croci, croci, croci. A Boneti c'è un cavallo che tira l'aratro, preso il cimitero; la terra fuma del lavoro recente, pronta a mandare i primi germi di vita sovra l'ossa dei morti.
Il lago di Doverdò è senz'acqua, un vero pantano, ma la quota 144 è intatta, coi suoi camminamenti e coll'imponente squarcio della nostra trincea che fronteggia quella austriaca. Par che dalle feritoie gli uomini si guardino e si sfidino ancora. Deserta la strada di Jamiano, sempre più triste l'ampia vallata dominata dalle due quote, a sinistra la 219 tenuta disperatamente dai granatieri e dalla «Bari», a destra la 146, perduta nelle giornate di giugno, avanguardia dell'Hermada, che, sempre più fosca, sbarra lo sguardo e chiude il panorama.
E la dolina Tauben? Come è malconcia! Il gelo e le bufere han cosparsa l'infida scala e le umide grotte di detriti; i piccioni non vi sono più, anche la «spada di Damocle» è scomparsa. Le rovine di Jamiano e di Komarie biancheggiano al sole, silenziose immagini di morte. Il passo muove quasi automaticamente verso Sablici (qui è caduto il generale Ricordi), verso quota 100 (qui si raccoglievano i rincalzi prima di attaccare l'Hermada), verso Flondar (a Flondar eravamo giunti, noi, il 25 maggio, a Flondar tornarono, loro, il 4 giugno). Di qui si fan più folte le siepi di reticolato, più spesse le caverne, sempre più frequenti le croci.
Il camminamento «Sauro» odora ancora di calce e di catrame; nella «dolina grande» le porte dei ricoveri sono ancora socchiuse, come l'ultima volta che furono aperte; le tabelle indicano ancora la via ai «posti di combattimento» e ai ricoveri. Una freccia manda: «Alle doline Trincheri e Napoli», un'altra: «Al camminamento Battisti».
Si domina da qui tutto il campo di battaglia di Jamiano, il vasto imbuto dentro il quale ogni bocca dell'Hermada vomitava il suo piombo; nel fondo era la nostra ultima trincea, tenuta dal 245° fanteria, nel mezzo la dolina dell'acqua, «la fossa dei leoni», dov'era il comando di reggimento, coi fedeli siciliani.
Il piede oramai fatica, ma il cuore ci porta invincibilmente verso l'Hermada, che guarda e pare che aspetti. Quota 146, Medeazza! Altri ricordi, altro sangue. E quanta strada ancora per arrivare alla meta! Ma, prima di attaccare l'erta finale, lo sguardo si riposa in una valletta erbosa, macchiata da cespugli, rigata di molte linee di cavalli di Frisia; sembra un luogo di riposo, ma, nel mezzo, pozzi profondi scavati in viva roccia, ai quali si discende con scale e mulinelli, avvertono che qui il nemico stava al sicuro e in agguato.
Di qui un ultimo sforzo. Il bosco è selvaggio di sterpi, di cespugli, di alberi, di istrici, di ferro spinato, di ogni risorsa della natura e dell'arte. Il piede affonda in buche, in forre, in trincee sconvolte o in altre appena tracciate, in bocche di lupo, in grovigli inavvertiti. Quanta fatica a salire, in una giornata di pace...! Si volta a destra e si guadagna il rovescio del monte: il bosco di pini è tutto bruciato. Ora si comprende come i bollettini ripetessero che l'Hermada era in fiamme; non era una semplice immagine, questa! E, anche qui, grotte, ricoveri, camminamenti, caverne per atiglieria, reticolati. E croci, croci, croci, sempre croci! Questo Carso è tutto una croce; per noi e per loro. Finalmente si tocca la cima, quota 323, aspra, rocciosa, ineguale, rotta da camminamenti profondi e da più profonde caverne.
L'Hermada! La meta sognata e mai raggiunta! Di qui l'Austria sciabolava il cielo coi suoi riflettori; di qui fulminava coi sui cannoni il terreno della sottostante battaglia. E, di qui, tutto il Carso si spiega agli occhi in un vasto quadro annebbiato: dalle ondulate alture di Doberdò alle quote ineguali del San Michele, alle piramidi bianche dei Faiti e del Golnek, alle arse rovine di Castagnavizza, alle boscose pendici dello Stol, alle più lontane foreste di Ternova. Tutta la pianura martoriata di San Pietro, di Ronchi e di Monfalcone si umilia ai nostri piedi, e, verso il mare, la grigia palude del Lisert e la celeste foce del Timavo e le superstiti torri di Duino, e, più giù ancora, la lingua evanescente di Punta Sdobba...; tutto par che si umilii davanti a questa altura del Querceto, lungamente tentata e uscita indomata dalla terribile e lunghissima prova.
*
Un barlume di sole venne a colorire il fosco tramonto, ed io bevvi in quella luce come per fermare in uno sguardo tutta la squallida visione del Carso; e salutai ogni valle e ogni cima, baciai ogni ricovero e ogni croce, dalla vicina e sconvolta Flondar alla lontana e oramai erbosa Oslavia.
Morti del Carso! Nessuno al mondo più di voi ha sofferto prima di morire, ma nessuno è caduto per causa più grande, per vittoria più pura. Per voi, che qui teneste il monte e la dolina, pugnando e vegliando, crollò il vecchio impero mostruoso; per voi, sulle rovine del mondo crollato, sorge oggi un mondo novissimo. Che questo mondo, o morti, sia più giusto e più pio, perché non per assicurare ai pochi esuberanza di gioie e ribadire le sofferenze ai moltissimi avete dato il sangue alle zolle... Non è vero? Tocca ai vivi rispondere.
Monti del Carso, addio! |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|