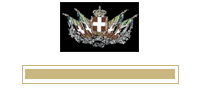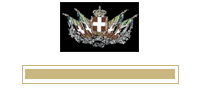| |
|
|
| |
:: Aggiornamento sito - Donazioni ::
|

Cari visitatori/iscritti di Fronte del Piave, Fronte del Piave ha bisogno del vostro aiuto.
È arrivato il momento di aggiornare tutto il sito.
------------- Aggiornamento -------------
Siamo felici di potervi comunicare che l’aggiornamento del sito è iniziato e la prima fase è completata, ma siamo ancora lontani dalla fine dei lavori e dalla cifra necessaria.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato fin ora e speriamo molti altri si uniscano a noi per salvare Fronte del Piave.
Maggiori informazioni e aggiornamenti qui. |
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
|
La miracolosa ed eroica avventura del capitano Ercole Ercole.
(1917)
Nelle prime luci d'un mattino calmo e radioso, due squadriglie mossero all'investimento dei campi nemici.
Viaggio calmo e regolare. Dinnanzi e quasi perduti nelle prime luci rosee dell'aurora, e già oltre la Vojussa, tra la sterminata piana acquitrinosa della palude di Licet Literbuf ed il lungo dorso montano delle colline di Malizia, sono i quattro Savoia-Farman che corrono decisi alla loro meta, volteggiano di già sui bersagli, osservano, colpiscono, si aggirano in ampie spirali sugli attendamenti, sopra i parchi di carreggio, sul nodo stradale, e si muovono in evoluzioni ritmiche, quasi legati nello spazio immenso da un comando unico, come una squadriglia di cacciatorpediniere che batte il mare.
Poi i Caproni che corrono per l'aria verso una meta più lontana. Ed ecco nella rapidissima corsa pel cielo calmo e terso, per l'aria limpida e frizzante, la immensa palude, il tortuoso Semeni scintillante sotto i primi raggi del sole, la piana folta di pinete di Divjaka e lo Scumbi maestoso nella sua foce amplissima e giallastra, il massiccio Kapo Laghi e finalmente, avanguardia di Durazzo, il piano brullo, infinito di Kavaja e le case numerose delle borgate disseminate su due file normali ed un altro folto gruppo di caseggiati.
E qui le prime avvisaglie della guerra nel cielo.
Gli hangars, situati a sud del paese, hanno già spalancato i loro battenti e quando il primo Caproni cosse su di loro e gli altri bersagli celati nella borgata, lasciando cadere grosse bombe che scoperchiano i tetti, sgretolano i muri, squarciano i magazzeni, sollevano immani colonne di fumo e di terriccio, già scorge sotto di sé, a quota bassa, due apparecchi nemici.
Ma di ciò nessuno si preoccupa. Il secondo Caproni si indugia per qualche tempo nello spazio, spiraleggia sopra i bersagli, attende che il diradarsi del fumo e della terra sospesi nello spazio, gli permetta di osservare i risultati del tiro e di scegliere nuovi obbiettivi da colpire. Poi, mentre i due velivoli nemici, tardi nei movimenti, e pigri nell'ascesa tentano di portarsi di fianco o sopra il nostro apparecchio, questi inizia la sua opera di distruzione. La pioggia di bombe è ancora più intensa. Il fuoco ancor più micidiale. I grossi calibri raggiungono tutti i bersagli ed i piccoli battono le contrade, la campagna immediatamente a ridosso dei caseggiati, e sulla quale fuggono terrorizzati soldati ed indigeni. Di sotto è per qualche minuto un inferno. Si sfasciano alti caseggiati, volano per l'aria nuove macerie ed il paese è tutto preso, tutto gravato sotto un nuvolone giallastro.
Un nuovo più ampio giro sulla posizione efficacemente battuta, poi ecco drizzata la carlinga verso l'Adriatico, verso l'isola di Saseno lontana ma distinta, mentre dal paese, che si perde nella lontananza, si drizzano al cielo densi pennacchi di fumo ed i due velivoli austriaci ansano in una vana rincorsa.
E' sulla via del ritorno, così come dopo ogni impresa: da Lubiana, da Trieste, da Fiume e da Durazzo stessa, che si ingaggia la decisiva lotta nel cielo.
Gli apparecchi nemici da caccia si erano elevati nel cielo da Divjaka, dove operavano i Savoia-Farman e ad una quarantina di chilometri a sud dal luogo dove i Caproni stavano contemporaneamente operando. L'allarme s'era propagato con qualche lentezza, nel mattino che aveva forse trovato pigre ed incerte le vedette: ma non giungeva tardi. Erano troppo addentro nel territorio nemico i grossi apparecchi italiani perché potessero sottrarsi all'attacco. E poi non l'avrebbero mai rifiutato il combattimento. Lo sapevano gli austriaci e su ciò confidavano e temevano. Non s'era forse svolto poco più di un mese prima, un serrato e furioso duello aereo fra otto apparecchi proprio sulla baia di Durazzo, nel cuore del territorio nemici a quasi novanta chilometri dalle linee italiane? Non s'era di proposito gettato contro un Fokker in uno dei più appassionati duelli aerei, l'eroico capitano Pesci che immolava la sua vita nel gesto ardito, nella sfida audace?!...
Si sarebbe dunque svolto nel cielo, il secondo epilogo della rinnovata audacia italiana.
LO SCONTRO AEREO.
Un primo Fokker drizzatosi fulmineo mentre le prime bombe lanciate dai Savoia-Farman devastavano gli accampamenti di Divjaka, s'era buttato come un falco sui quattro apparecchi italiani. D'ogni lato portava l'attacco: inabissandosi dall'alto, portandosi improvvisamente sui fianchi, tentando di aprirsi un varco fra la squadriglia che ancora tutta spiegata in linea di battaglia, ben collegata ed unita, stava riprendendo la via del ritorno. Ma ogni attacco s'era spuntato contro questa alata barriera che lanciava dalle sue mitragliere ventate di fuoco, e s'andava spostando sull'Adriatico per svolgere su di un campo meno sfavorevole la sua azione controffensiva.
Infine il Fokker scoraggiato, abbandonava la lotta per raggiungere verso il nord di il compagno che come un piccolo punto si delineava nello spazio verso Kavaja.
Segno glorioso della breve, serrata ed incruenta lotta: la carlinga di un Savoia-Farman crivellata nella sua aguzza prora da una piccola rosa di buchi. I proiettili perforanti austriaci erano sgusciati fra le gambe di due degli audaci navigatori dell'aria.
Ma non era che una tregua. La lotta veniva spostata al nord. Sulla via del ritorno i due Caproni si seguono in linea ad una distanza di circa 800 metri e poiché non è conveniente attaccare il primo, che potrebbe ricevere immediato aiuto dall'altro, si tenta la sorpresa sull'ultimo. Infatti quel punto ch'era segnato appena sul cielo di Kavaja, ha seguito in una fulminea discesa il volo del secondo Caproni, e l'attacco è seguito improvviso e decisivo. I nostri navigatori hanno appena il tempo di avvertire la minaccia e di gettarsi ai loro posti il combattimento.
Il primo a scorgere il Fokker è il capitano Corbelli che sta alla mitragliatrice posteriore. Una toccata di spalla al capitano Ercole e questi cede i comandi al brigadiere Mocelin e si porta alla mitragliatrice anteriore. Da qualunque parte si presenti l'attacco, il nemico avrà degna risposta. Intanto il capitano Ercole tenta di richiamare l'attenzione del primo apparecchio sparando qualche colpo in alto. Ma gli altri non se ne accorgono che troppo tardi.
La manovra del Fokker è rapida e facile. Si trova a 3200 metri d'altezza, 500 circa sopra il nostro apparecchio, e scende a “gradini” con piccoli planès e con brevi richiami in linea di volo. La distanza diminuisce rapidamente. Il capitano Corbelli, imperturbabile, corregge il puntamento della mitragliera ed attende. Un'ultima “picchiata” del Fokker, ed eccolo nella sua inclinazione massima, apparecchio e mitragliera puntati su tutto il fusellage del Caproni.
Sembra lo debba investire violentemente di coda. Le due mitragliere nemiche aprono il fuoco nello stesso tempo.
Per pochi decimi di secondi il crepitar secco dei colpi domina l'ansar dei motori. Ma è un'ondata terribile quella che investe dall'alto in basso la carlinga del Caproni. Il capitano Corbelli colpito al petto, abbandona la impugnatura della mitragliere, alza le mani e s'abbatte di schianto nell'angusta passerella. Le altre pallottole perforanti crivellano i grossi serbatoi di rame, li trapassano ed investano tutta la prora della carlinga.
Il brigadiere Mocelin ha un sussulto, lascia le leve di comando e si abbatte su di un fianco, mentre due rivoli rossi di sangue gli solcano dalla fronte tutto il viso. Il capitano Ercole non può muovere il braccio sinistro.
Quasi nello stesso istante il Fokker, sfiorando tutto il Caproni, scende vorticosamente a picco nello spazio...
LANCIATI NEL VUOTO.
Ma v'è ancora un'anima viva sull'apparecchio di morte che abbandonato a sé si inabissa, quasi per seguire il tragico destino dei suoi piloti.
Il capitano Ercole, più che vista ha intuita la fulminea e tragica azione, e quando il Caproni sta iniziando la paurosa caduta, egli è già in piedi aggrappato ai bordi della carlinga per raggiungere il seggiolino di guida.
E qui comincia l'odissea del suo eroismo fra i monti; sulla morta aeronave, nella visione d'una fine spaventosa, egli non lascia prevalere l'istinto della conservazione, ma su tutto impone la calma, la sicura scienza del guidatore. Non giuoca il tutto per il tutto; contende nella manovra, la sua vita alla morte. Raggiunge il seggiolino, s'aggrappa ai comandi, gira il volante solo di quanto è necessario per non mutare in schianto la catastrofe che già sembra inevitabile. Sotto le sue mani (una è contratta nello spasimo della ferita che ha al braccio sinistro) egli calcola lo sforzo che può, che deve subire l'apparecchio per rimettersi in linea di volo. Ed è un calcolo freddo, pacato, un richiamo progressivo e quasi dolce dei timoni nel precipizio, fra la violenza dell'aria che turbina d'attorno, mozzando il respiro, nella visione netta, fatale, della terra che si avvicina rapidamente tutta irta di mille ostacoli e sembra allarghi mostruose braccia per accogliere il naviglio dell'aria in un ultimo amplesso.
Bisogna pensare a questo immane sforzo di volontà: bisogna figurarsi la tragica visione di un convoglio di morti lanciato perdutamente nello spazio e conteso all'ultima ruina da un moribondo: bisogna portarsi accanto a questo eroe e vederlo così minuscolo com'è, così perduto nella vastità della carlinga intrisa di sangue e cosparsa di benzina – la testa di un compagno ucciso poggiata sulla spalla ferita e dolorante – lottare senza disperazione contro la morte più disperata. Ed allora soltanto si sente, si comprende la maestosa e terribile grandezza del gesto!
A 300 metri dal suolo il generoso velivolo dolcemente si rimette in linea di volo, mentre il motore di destra, chissà mai per quale miracolo riprende a funzionare. Di sotto il terreno è ampio e brullo. L'ultimo planè è compiuto con precisione ed in breve l'apparecchio è fermo sul campo, addossato ad un'altra siepe.
Per qualche tempo rimane silenzioso, il gigantesco aeroplano. Non clamore d'intorno, non una voce, non un allarme. Silenzio nel cielo e sulla terra. Una pace strana sulla pace dei morti! Ercole è ancora con le mani aggrappate al volante. Non può muoversi, non osa: è come prostrato da una immane stanchezza, preso da un irresistibile bisogno di riposo, di pace. Poi è la stessa quiete sinistra che lo circonda, quella che lo richiama alla realtà. La testa del povero Mocelin, gli grava sulla spalla, quasi sulla ferita. La scosta e dolcemente la scuote, tenta deviare i due lenti rigagnoli di sangue che imbrattano il viso; lo chiama per nome; gli alza un braccio che scivola, nella rigidità e nel peso grave della morte, su di un serbatoio.
Allora si leva e come vede dietro a sé tutto steso il capitano Corbelli, si china su di lui, gli tocca la fronte diaccia, gli accarezza il bel viso freddo, cereo, composto nella calma e dolce serenità che aveva nei bei giorni della vita, gli apre la giubba e quando scorge sul petto glorioso una piccola e spessa rosa di buchi, s'inginocchia e piange. Ma il martirio non ha ancora fine!
La sommessa prece pei morti che Ercole dice nel sul pianto doloroso è interrotta bruscamente, stornata, da urli o da imprecazioni. Un energumeno albanese gira forsennatamente attorno all'apparecchio e sfoga la sua rabbia a colpi di tridente nei fianchi della carlinga, sulle ali inferiori. Ercole è come stupito. Si leva, guazza nel miscuglio di sangue e di benzina, arriva alla prora della carlinga e con tranquillità, col polso fermo, così come se dovesse compiere un'altra manovra, leva da una custodia la Mauser. Spara e il malcapitato indigeno cade sotto l'apparecchio.
Un pericolo s'è però improvvisamente drizzato. Qualcuno ha dunque visto ed è accorso. Altri accorreranno ed avranno a guida la secca detonazione della pistola. Bisogna compiere il sacrificio: distruggere, distruggere subito e ad ogni costo. Ma come? Come, se i due morti compagni giacciono ai loro posti di combattimento, sereni, composti e quasi sembrano implorare che nessuno li tocchi, che nessuno violi quello che fu l'orgoglio loro in vita, ed ora la tomba? Come levarli dall'alta carlinga deporli sul terreno e comporli lontano dall'apparecchio? Come? Come, con un braccio spezzato, con le forze prostrate dalla lotta contro gli elementi?
Ed il tempo passa veloce, il pericolo incalza. Da lontano si profilano figure d'armati. Su nel cielo, alto si delinea un punto.
IL ROGO SACRO.
Una sorda angoscia stringe l'animo del capitano Ercole. Egli gira smarrito attorno al velivolo intatto. S'allontana di qualche passo. Ritorna. S'aggrappa ai pedalini della carlinga. Li lascia. Si getta a terra scorato, piangente, rannicchiandosi sotto il suo apparecchio, sotto la tomba dei suoi morti, mentre la rossa rugiada che stilla dalla navicella imperla dolcemente la terra e lascia goccie di rubini sulle robuste anse del carrello.
Poi d'un colpo, come animato da una forza e da volontà sovrumana, sale freneticamente alla carlinga, la scavalca, s'abbatte ginocchioni fra i due morti, e grida nel pianto: «perdonatemi! fatemi pietà dell'ultimo oltraggio! Perdonatemi! non sono io! è la patria!»
E con la mano sana che sembra abbia voluto raccogliere nella sua palma, nelle sue dita, tutta l'ultima energia d'un corpo e d'una volontà, strappa i rubinetti, contorce. Poi scende, mentre la benzina invade e si sparge copiosa sulle ali, ed appicca il fuoco. S'allontana barcollando per un centinaio di metri, e s'abbatte di schianto nel più folto d'una siepe: tutte le energie l'hanno abbandonato. Dietro arde il rogo immenso. Una densa colonna di fumo nero ed acre s'alza in molli spirali verso il cielo, ed un crepitio secco di fucileria, picchietta nell'aria. Le munizioni di bordo esplodono.
Quando lo spasimo acuto della ferita lo richiama alla realtà delle cose, attorno alle fumanti rovine del Caproni è raccolta una piccola folla, che commenta impaurita e sorpresa. Un prete ortodosso, un gruppetto di bambini, delle donne, qualche indigeno armato. Più lontano e fermo, un grosso Aviatik che s'è appena posato sul terreno. Due aviatori austriaci scendono, si dirigono verso il Caproni, s'avvicinano ai monconi fumiganti, scrutano toccano, scrollano il capo, ritornano al loro velivolo e ripartono.
Il dramma è finito per gli avversari nostri. Anche la folla dirada e presto scompare.
Il capitano Ercole è sempre appiattato nella siepe, colla ferita che gli sanguina, le labbra arse da una sete insaziabile, la fronte in fiamme, l'animo in tumulto. Un gemito, lo stormir di una fronda potrebbero tradirlo, farlo consegnare vivo in mano agli odiati nemici, concedere loro l'ultima soddisfazione.
Bisogna resistere ancora, vincersi e vincere ad ogni costo. E qui si compie l'ultimo e più fulgido atto di questa breve epopea.
Due pensieri, due desideri, due amori campeggiano e dominano nell'anima dell'invitto dominatore dell'aria: «libertà e patria». Conseguire la prima per potersi ancor e sempre dedicare all'altra.
E tutto quel che verrà poi – l'affanno della lunga e dolorante fuga per le sterminate pianure, su per le selvose valli, per i nudi ed aspri dorsi montani, entro le fetide ed immense paludi; i tormenti della fame; le angoscie dei momenti decisivi; gli spasimi della disperazione; gli impeti folli delle decisioni estreme – piccoli epiloghi d'un atto decisivo.
Bisogna affermarsi in un'idea precisa, in una volontà ferma ed incrollabile: pronunciare il voto e giurare di compierlo al prezzo di indicibile sofferenze fisiche e morali.... ed ecco come egli stesso descrive la sua fuga.
L'AVVENTUROSA FUGA.
«Bruciato l'apparecchio, mi ero nascosto in un folto cespuglio. - Vidi allontanarsi il prete, i bambini e l'aeroplano austriaco «cosa fare allora?» - Prima passai un esame alla mia persona.
«Per terra, scorrendo lungo la manica il sangue aveva formato un'ampia chiazza, tolsi la giubba e rimasi allibito vedendo la mia ferita. Era ampia, slabbrata, piccoli brandelli di carne si erano attaccati alla camicia ed il sangue abbondante usciva come da una polla d'acqua. Con un lancio delle scarpe strinsi il braccio superiormente e constatai subito una diminuzione di perdite, ma il braccio si moveva a stento: era forato per tutto il suo spessore ed il muscolo deltoide quasi staccato. Una fuga in quelle condizioni mi sarebbe stata impossibile. Da lontano una casa con i distintivi della Croce Rossa mi invitava. Con l'unico soldo che avevo in tasca volli chiedere alla sorte un consiglio e per tre volte consecutive la sorte mi indicò di costituirmi. La mia decisione però era presa, prigionia o morte erano equivalenti quindi meglio tentar la fuga. Progettai di allontanarmi, prima nell'interno indi indirizzarmi verso le mie linee affrontando volta a volta gli ostacoli. Possedevo un fazzoletto, un soldo, otto sigarette, otto cerini ed una catenina d'oro con una medaglia di S. Elia. Non ero certo molto ricco per intraprendere un viaggio podistico circa di 180 chilometri. Truccai un po' l'abbigliamento per nascondere la mia qualità di ufficiale, indi rapidamente traversai la pianura che si stendeva davanti a me.
«Girando un sentiero mi comparve ad una certa distanza un albanese, non potevo né nascondermi, né tornare indietro, dovetti quindi affrontarlo: passando vicino gli feci il saluto all'orientale e la cosa passò liscia.
«Sopraggiunse la notte: affranto dalla lunga marcia compiuta sotto il sole cocente non ostante la fame e le fitte dolorose della ferita mi distesi lungo un albero abbattuto, addormentandomi profondamente. Al primissimo albeggiare mi svegliai e non ritenendomi più sicuro in quel posto ripresi a camminare per allontanarmi sempre più dal luogo del disastro. Per calmare la sete scesi in un fossato con le pareti a picco dove avevo scorto dell'acqua; mentre bevevo sentii dei rumori, e delle voci. Erano dei soldati austriaci che percorrevano la strada, per nascondermi mi arrampicai lungo la parete del fossato, aggrappandomi alle radici di un arbusto, che fortunatamente rovinò non appena i soldati furono passati. Bisognava essere prudenti e non muoversi durante le ore del giorno; difatti mi nascosi in una macchina aspettando la sera. Fu una giornata eternamente lunga e cercai vanamente di dormire.
«La notte seguente mi indirizzai verso le mie linee e tranne una caduta dentro una trincea mascherata, che mi graffiò tutto il volto, nessun incidente si verificò, il digiuno e la sete mi tormentavano, per giunta mi sentivo colpito dalla febbre che mi seccava la sola, mangiai dell'erba e mi sembrò squisita e mi inumidii la gola succhiando la rugiada delle foglie. Riposai tutto il giorno seguente alternando il sonno ad ansiose ma infruttuose ricerche di cibo e di acqua. Proseguendo nel cammino la terza notte ebbi la ventura di poter rubare delle mele in un giardino, con le quali calmai gli stimoli di fame, ero però sfinito avevo perso troppo sangue e la mattina del terzo giorno alle prime luce mentre, mi indirizzavo verso una capanna, svenni. Mi risvegliai non so dopo quanto tempo. Un vecchio con un giovanotto di circa diciotto anni mi frugava il petto, bruciavo dalla febbre e dalla sete e non capii nulla di quanto mi dissero; faccio segno di aver sete e un po' d'acqua che mi danno mi ridà la vita, tento rialzarmi, ma casco ancora. I due albanesi allora mi prendono per la testa e per i piedi e mi portano nella capanna dove vengo rifocillato. Conoscevo qualche parola d'albanese e compresi che la mia medaglina li aveva molto impressionati.
«Ero cristiano e loro come cristiani sentivano il dovere di aiutarmi. Poco dopo comparve una vecchia ed una giovinetta con degli occhi stupendi, mi guardavano e mi parlavano con molta compassione chiedendomi dove ero ferito. La ferita era orribile a vedersi, la pallottola probabilmente scoppiando, aveva prodotto un'enorme squarciatura; la vecchia impietosita trasse dal seno un pezzo di sapone bianco, e con le mani bagnate formò una saponata che ripetutamente applicò sulla ferita, pensai allora che non mi restava nessuna probabilità di salvarmi da una infezione. Con cenno e con parole feci comprendere la mia idea di rientrare a Vallona e che se mi avessero aiutato, avrei fatto recapitare a loro molto denaro. Capii però che il mio abbigliamento garantiva poco e per vincere la loro diffidenza dissi che ero figlio del governatore di Vallona mostrando a conferma un lembo di camicia sulla quale era lo stemma di un fornitore della R. Casa. Allora decisero di aiutarmi e fu concretata la mia partenza per la notte seguente, poiché prima bisognava accertarsi se sul ponte vi erano sentinelle. Nell'attesa però non potevo rimanere nella capanna, gli austriaci avevano requisito il latte delle loro bestie e due volte al giorno venivano a ritirarlo. Fui inviato quindi in una boscaglia sopra una collina. Durante la notte piovve abbondantemente e la mattina uscii dalla boscaglia per asciugarmi gli abiti al sole, due soldati austriaci stavano mungendo una capra, appena mi videro scapparono impauriti, probabilmente la capra non era loro, ed erano scappati ritenendomi proprietario. Nel pomeriggio il buono albanese venne a portarmi un po' di pane di grano-turco e un po' di formaggio e molto sconfortato mi annunciò che sul ponte vi erano le sentinelle austriache e che occorreva il passaporto per transitare. Si decise di confezionare una zattera per il passaggio del fiume poiché le condizioni del mio braccio non mi permettevano di attraversare a nuoto. Sull'imbrunire l'albanese viene a riprendermi e con il figlio rechiamo sulle sponde del fiume dove con rami si costruisce un grosso fascinone che doveva servire da barca. Il lavoro durò un paio d'ore e la zattera fu nascosta in mezzo a dei cespugli indi ci recammo nella capanna. Questa era bassa e costruita di paglia e canne, nell'interno un tanfo di carne bruciata e di fumo denso rendevano più buio e più tetro l'ambiente. Mi sedetti a terra alla guisa turca presso un tavolo bassissimo; avevo presso di me l'albanese con il figlio e separati da noi, pure presso un tavolo bassissimo la vecchia che mi aveva bagnata la ferita e la figlia bella creatura dalla tinta olivastra e dagli occhi nerissimi e belli.
«La mia vita era sospesa ad un filo tenue, se riuscivo salvo dall'avventura nella quale mi ero cacciato, forse non mi salvavo da una infezione tetanica. Gli orli della ferita erano diventati neri, dall'interno di essa con uno spino di siepe avevo levato un pezzo della mia pelliccia un puzzo di cadavere emanava da essa, la febbre mi bruciava e mi rendeva la gola arsa. Guardai intensamente quegli occhi luminosi, volevo morire con una dolce visione dei miei.
«Potrei campare ancora cent'anni, non dimenticherò mai lo sguardo di compassione ch'ella mi ricambiò. Fu come una frustata, mi sentivo compianto, bisognava lottare, bisognava vincere. L'albanese portò sulla nostra tavola un capretto arrostito con il quale bisognava prima consultare l'oracolo, indi si poteva mangiarlo. Fece un cenno alla vecchia, questa frugando nella paglia prese un lunghissimo coltello con la lama rabescata, e staccò dal soffitto la lampada di creta ad olio che mise sul tavolo. Il vecchio squarciò il capretto indi colle mani frugando lentamente nella carne sanguinolenta cercava l'osso scapolare per consultarlo; trovato che l'ebbe lo pulì accuratamente e lo passò davanti alla lampada guardandolo in trasparenza; cercava una certa macchia che doveva essere un sicuro vaticinio per un viaggio. La consultazione mi parve durasse un secolo, a seconda dell'espressione del vecchio il mio animo passava attraverso mille emozioni. Anche tutta la famiglia guardava ansiosa, ma come me guardava spesso anche il capretto. Finalmente il vecchio emise un'esclamazione di gioia. Potevo partire, il vaticinio era favorevole!
«Mangiai del capretto con vorace avidità, indi ci alzammo ed iniziammo i preparativi per la partenza. Cedetti la mia giubba di pelle, le mie scarpe ed il maglione, in cambio ebbi un camicie in brandelli che posi sopra alla giubba da ufficiale, un berrettino ed una specie di scarpe formate da un pezzo di pelle che con cinghiette si fermava alla pianta dei piedi. Uscimmo all'aperto, tutto vollero baciarmi ed io lasciai alla giovinetta la catenina d'oro che avevo al collo. Con il vecchio ed il figlio ci recammo sulle sponde del fiume, mettendo la zattera in acqua ed aggiungemmo ad essa un lungo palo che doveva servire da remo.
«Con l'unico braccio valido guidai la zattera nella corrente, ma causa un colpo del timone che aveva urtato nel fondo caddi nel fiume. Il buon vecchio mi tirò su e mi tolse la carica di timoniere.
«La traversata durò lungamente, ma senza inconvenienti giungemmo alla riva opposta. Ero fradicio d'acqua battevo i denti dal freddo ed inoltre la ferita mi dolorava terribilmente; mi rannicchiai a terra per scaldarmi. Il vecchio mi scosse; mi salutava perché doveva rientrare. I raggi della luna illuminavano il mio volto ed egli forse nei miei occhi lesse un'implorazione; ero un fardello umido di cenci sanguinolenti; il mio viso emaciato dal digiuno e dalle fatiche era solcato di profondi graffi.
«Non chiesi nulla, ma forse il buon albanese pensò che non era umano abbandonare a se stesso un mucchio di cenci che un piccolo aiuto poteva ridare alla vita, certo che lanciò un grido al figlio lasciato sull'altra riva, e decise di accompagnarmi. Mi alzai e facendo appello a tutte le mie energie riprendemmo a camminare. Faticosamente sostenendomi ad un ramo potei camminare fino all'alba calmando l'arsura della febbre coll'acqua di pozzanghere. Il giorno riposammo, ma appena scuro riprendemmo la marcia verso Vallona. Ancora oggi penso con qualche brivido all'ultima notte passata nel territorio albanese.
«Fin dalla mattina non avevo messo nulla nel mio stomaco, l'unico pezzo di pane che il buon vecchio mi aveva dato era stato diviso in due ed anche lui aveva fame. Dopo qualche ora di cammino allo stremo di forze caddi. I miei piedi ormai privi delle scarpe primitive erano ridotti una massa informe, sanguinolente, piena di ferite e di spini. Nella notte intravidi dei fasci luminosi che solcavano il cielo di Vallona essi mi richiamavano alla realtà. Mi rialzai e sempre animato dalla mia fede proseguii la marcia. Fummo costretti ad attraversare un terreno pieno di acquitrini e di paludi dove spesso si affondava fino al mento. Anche l'albanese si trascinava faticosamente e a un dato momento mi disse che non intendeva più proseguire. Gli rinnovai le promesse di danaro, ma nulla valse; allora ricorsi alla minaccia, per quanto in cor mio pensavo di non adoperare mai questo mezzo, la minaccia fu efficace, l'energia con la quale agitai il bastone lo persuasero; ed allora fu lui che dovette seguir me poiché non sapeva più orientarsi.
«Io forse non lo avrei trascinato nell'avventura che poteva finire tragicamente, ma temevo che se per disgrazia io fossi ancora svenuto non mi sarei più rialzato, mentre la sua presenza mi infondeva coraggio. Per attraversare le linee austriache progettai di gettarmi nella palude che la Vojussa formava sfociando al mare.
«I nostri avevano i trinceramenti sulla riva sinistra, mentre gli austriaci avevano i propri a molta distanza dalla riva destra.
«Nella palude impraticabile gli austriaci non potevano avere forze: decisi di attraversare il paludeto e risalendo alla riva destra che era incassata e fuori della vista nemica portarmi in corrispondenza delle linee italiane, che io avrei raggiunto a nuoto. L'albanese mi seguì nella faticosa e dolorosa marcia, nella palude rischiarata dalla luna l'acqua arrivava al petto sicché per lunghe ore fu impossibile sedermi e riposarmi. Tranne una pattuglia austriaca che potemmo evitare e dei cignali, tutto proseguì senza incidenti. Era ancora scuro quando giungemmo in un punto della Vojussa ch'io giudicai potere attraversare e nuoto; contavo di mandare a riprendere il vecchio con una barca. Mi riposai alquanto indi mi gettai in acqua, ma la corrente fortissima mi travolse; con un braccio solo e con uno sforzo sovrumano riuscii a tornare sulla riva; ero salvo ancora, però bisognava rinunciare alla traversata a nuoto.
«Non sapevo più come regolarmi; il vecchio mi guardava attendendo da me una risoluzione; provai a gridare, gridai ancora finché nella penombra dell'alba intravidi una sentinella.
«Con tutta la forza dei miei polmoni gridai Italia, dall'altra sponda mi si rispose e dopo poco vidi muoversi una barca.
«Quando finalmente potetti mettere piede sulla riva sinistra fuori da ogni insidia baciai la terra italiana come una cosa cara alla quale si era dato addio per sempre e che invece si ritrova». |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
 |
|